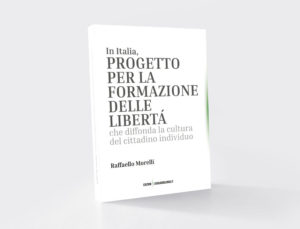Decima parte della CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL LIBERALISMO
4.2 b .2 Fino all’avvento del Partito Nazionale Fascista . 4.2 b .2 a – Il Governo Giolitti IV e la conquista in nord Africa – La crisi del Governo Luzzatti venne quindi causata da fibrillazioni parlamentari collaterali alla riforma elettorale (e probabilmente ancora dai passi di Giolitti per tornare al Governo). Peraltro nel paese circolavano già da alcuni mesi tensioni innescate dai modernisti e dai nazionalisti . Ambedue questi gruppi, pur ben distinti tra di loro, diffondevano una concezione politica basata sull’esaltazione. Dei modernisti ho già scritto sopra. Avevano un’influenza extra letteraria con il manifestare un’idea della realtà romanzata (l’iniziativa politica avrebbe dovuto corrispondere al militarismo interprete della guerra, che sarebbe l’igiene del mondo). Dei nazionalisti va detto che, dopo qualche anno di attività, alla fine del 1910 si era tenuto il primo congresso dell’Associazione Nazionalista Italiana, ed era stata avviata una campagna appoggiata dal mondo cattolico, per la conquista di una colonia nel Nord Africa, nel nome dei gloriosi destini dell’Italia.
Il quarto Governo Giolitti venne votato in pochi giorni e sin da subito riaffermò in Aula l’esigenza “dell’ampliamento del suffragio per una più diretta partecipazione nella vita politica del Paese” (attivando il lavoro che un anno dopo sfocerà nella nuova legge elettorale) ed anche di provvedimenti, quali l’assicurazione sulla vita in mano allo Stato per finanziare le pensioni operaie, con l’obiettivo di arginare le pressioni socialiste. Il Governo, composto da liberali e da alcuni radicali, non venne votato dalla Destra.
Nelle stesse settimane ci furono le celebrazioni del cinquantenario del Regno, in Parlamento e in varie città, con importanti esposizioni, monumenti e pubblicazioni. Il clima assai euforico di esaltazione Risorgimentale, alimentava non poco le speranze di un Regno sempre più forte tra le Nazioni e fornito di una analoga forza espansiva indirizzata verso l’Africa meno sviluppata, alla ricerca delle risorse di cui l’Italia mancava. IL clima euforico faceva breccia nei giornali ritrosi al colonialismo (quale il Corriere della Sera) e anche nel mondo sindacale e socialista , appoggiando l’idea di mettere le mani sulle regioni nordafricane della Tripolitania e della Cirenaica. In pratica il solo dissenso era espresso da Salvemini che in quello stesso periodo definì quelle zone uno scatolone di sabbia. E scrisse che la campagna militare serviva alla leggerezza delle classi dirigenti italiane per negare i problemi interni e trovare diversivi di avventure militari, funzionali ad interessi parassitari che sarebbero distrutti da riforme interne. In più Tripolitania e Cirenaica erano parte dell’impero Ottomano turco e gli ambienti cattolici secolari (del tutto al contrario del Vaticano) spingevano per la guerra agli infedeli non tenendo conto dei fallimenti di Adua, ma considerando che in quelle regioni del Nord Africa gli italiani erano già presenti con varie attività. Nel complesso, nei primi due mesi estivi, era in. atto una chiara manipolazione dell’opinione pubblica.
A fine luglio, il Parlamento andò in ferie senza aver affrontato l’argomento. Nelle precedenti quattro settimane, peraltro, il Ministro degli Esteri Antonino Paternò di San Giuliano – un liberale senza corrente da anni in solidi rapporti con Giolitti –pensava che le forti tensioni in corso sul Marocco tra Francia e Germania, erano un’occasione che l’Italia non avrebbe dovuto perdere (tra l’altro al fine di proteggere le zolfiere della Sicilia dalla possibile concorrenza dello zolfo nord africano nel caso fosse caduto in mano di una potenza europea). Iniziò fare pressioni scritte e di persona sul Re e sul Presidente del Consiglio perché preparassero un intervento militare, avendo l’appoggio di Sonnino, della stampa più importante ed sfruttando pure i rapporti molto tesi con la Turchia che da mesi per varie ragioni, , minacciava duri interventi contro le attività italiane in Tripolitania e Cirenaica. A differenza del Re, Giolitti era titubante, sia in chiave internazionale (pericolo di cadere nel vortice delle tensioni franco tedesche) sia interne (la forte opposizione socialista a fatti militari).
A settembre peggiorarono molto le relazioni con la Turchia e a fine mese, dopo serrati scambi diplomatici, il Re , ai sensi dell’art.5 dello Statuto Albertino, dichiarò guerra alla Turchia a causa dei ripetuti incidenti in nord Africa. Nei giorni successivi l’Italia sbarcò un corpo militare di 40.000 soldati e avviò l’occupazione sul terreno , allertando anche la flotta in tutta l’area meridionale mediterranea. L’azione militare, nonostante le rassicurazioni italiane, non venne apprezzata nel consesso delle potenze europee, neppure da quelle alleate. Peraltro, sul campo le operazioni, anche se contrastate più del previsto – per la convergente resistenza dei turchi e delle tribù africane – ebbero successo e ai primi di novembre Tripolitania e Cirenaica vennero annesse al Regno italiano. Gli scontri tuttavia continuavano a serpeggiare, visto che la Turchia riforniva stabilmente le armi.
In Italia l’operazione militare nel nord Africa contro l’impero Ottomano era largamente approvata, anche se era stata decisa e veniva gestita ai piani alti dello Stato, in particolare negli ambienti della Corona (visto che il Parlamento era chiuso da fine luglio e riaprì nell’ultima settimana di febbraio del 1912). Osservando gli avvenimenti con l’esperienza del dopo, va detto che l’acquiescenza di Giolitti nell’accettare le modalità di avvio della campagna militare faceva emergere un limite nella sua impostazione politica (a ben vedere già manifestato all’epoca dello scandalo Banca Romana). La sua grande abilità nel solcare le acque dei rapporti in Parlamento e in generale del confronto politico, si paralizzava quando le minacce al suo disegno liberale venivano da poteri ed entità estranee al confronto politico. Tali minacce partivano dall’esaltare il bene comune (fissato da loro stesse e dunque sempre presunto) senza approfondire le circostanze prima di affrontare il merito delle questioni. E Giolitti non sapeva come reagire, salvo il rispettare il volere della Corona quale punto fermo del Regno.
Alla ripesa dei lavori, le prime sedute parlamentari furono dedicate alla campagna nordafricana e tutti votarono quest’ordine del giorno: “La Camera, con animo riconoscente ed orgoglioso, manda un saluto ed un plauso all’Esercito e alla Marina che, segnalandosi nel mondo, mantengono alto l’onore d’Italia“. Insieme fu votata in pochi giorni la legge di annessine della Tripolitania e della Cirenaica, annotando che era un interesse vitale per l’equilibrio delle influenze politiche nel Mediterraneo, cui l’Impero Ottomano confliggeva di continuo. Giolitti chiarì che la legge era stata fatta “per determinare qual’è la meta cui il paese a qualunque costo vuol giungere, in modo che amici alleati, avversari sappiano quale è il punto oltre il quale l’Italia non potrà andare nelle sue concessioni” . Alla Camera la legge ottenne 431 voti a favore e 38 contrari (la. maggior parte del PSI eccetto 13), al Senato ottenne l’unanimità , nelle strade di Roma e in specie al Quirinale, vi furono enormi manifestazioni di giubilo. Dopo di allora, nonostante che nel nord Africa ed anche nel Mediterraneo meridionale proseguissero con successo le operazioni militari contro l’Impero Ottomano, questo tema divenne secondario a livello politico, per poi concludersi a metà ottobre con la pace con la Turchia , che riconobbe la posizione dell’Italia su quei fronti di contenzioso (in ogni caso in Tripolitania e Cirenaica la guerriglia con le tribù locali proseguì per quasi un ventennio).
4.2 b 2 b Il suffragio universale maschile – Da marzo 1912 e in vista delle politiche del 1913, il confronto politico si concentrò sulla questione della riforma elettorale in discussione finale già dalla primavera precedente. E verso metà giugno nacque la nuova legge elettorale che estese il voto ai cittadini maschi (né la maggioranza liberale né l’opposizione socialista accettavano il suffragio femminile, anche perché ritenuto troppo favorevole ai cattolici). Il diritto di voto era esteso ai maschi sopra ai 30 anni, senza alcun requisito di censo né di istruzione, mentre i maggiorenni fino ai 30 anni con alcune condizioni di censo (un’imposta annua di almeno 19,8 lire o un fitto annuo o un’imposta ad un Comune) o di prestazione del servizio militare o di titoli di studio (superato un corso elementare obbligatorio). Il corpo elettorale crebbe d’un colpo da 3,3 a 8,45 milioni, quasi un quarto degli abitanti. La legge sul suffragio universale fu un esempio di effettiva capacità riformatrice, che agisce dopo aver fatto maturare la consapevolezza della questione. Ed è appunto questo criterio che turba la cultura cattolica (del resto ancora oggi). Secondo questa cultura il suffragio universale non andava bene poiché non corrispondeva a riconoscere un diritto civile del cittadino bensì lo faceva dipendere dal criterio dell’esperienza, legata all’età o al servizio militare. Fin da allora fu chiaro che la cultura cattolica aveva un singolare duplice comportamento. A livello religioso riduceva la partecipazione dei fedeli all’ubbidienza alle decisioni della gerarchia, mentre a livello civile adottava il dover essere di principio senza tener conto del fatto che i diritti derivano da una maturazione nella quotidianità, che non è mai immediata. Di fatto, dalla critica della cultura cattolica sulla nuova legge elettorale trapelava la suggestione impositiva, connaturata ai valori religiosi.
Questo cambiamento realizzava una aspirazione dello stesso Cavour. Tuttavia, estendere il voto aveva implicazioni profonde, che tra i liberali pochi avvertirono. Che non erano gli ampliati interessi in contrasto, cosa fisiologica per i liberali. L’estensione avrebbe variato la percezione di idee e programmi politici. Man mano che il suffragio si allarga, diminuisce la percentuale dei cittadini con un elevato grado di attenzione al governo della cosa pubblica e ai suoi meccanismi concreti. Di conseguenza, riuscire a far conoscere davvero il proprio progetto assume man mano più importanza e le modalità con cui farlo conoscere tendono sia a divenire più “elementari” sia a dover essere più capillari. In altre parole, si erano poste le premesse perché fosse indispensabile, oltre ad avere idee politiche, anche organizzarle sul piano elettorale della cittadinanza.
La logica intrinseca al suffragio esteso non venne colta subito dai liberali ma il suo meccanismo contribuì a dissolvere la capacità politica di pesare del loro movimento. Vennero avvantaggiate da un lato le organizzazioni a carattere socialista (nello stesso periodo guidate dalla parte più rivoluzionaria), dall’altro lato, e soprattutto, le organizzazioni cattoliche, peraltro rimaste sempre attive sul territorio.
4.2 b 2. c L’artificio cattolico del Patto Gentiloni – Il fulcro fu l’Unione Elettorale Cattolica Italiana (UECI), nata nel 1907 per affiancare l’Azione Cattolica sorta l’anno precedente come associazione laica per la propaganda religiosa. L’UECI non era un partito bensì un braccio operativo impostato sull’enciclica Fermo Proposito (1905) che escludeva la separazione tra movimento cattolico e azione politica dei cattolici rispettosi degli indirizzi spirituali.
Il conte Vincenzo Gentiloni, nominato dal Papa presidente dell’UECI nell’estate di tre anni prima, ne irrobustì le strutture in senso capillare. E quando fu varata la riforma elettorale, Gentiloni, in vista delle elezioni politiche dell’anno successivo, pensò di giovarsene secondo l’insegnamento della gerarchia. Così, senza arrivare ad un partito (non pochi dicono su incarico del Papa) , definì le condizioni che consentissero agli elettori cattolici di votare un candidato alla Camera. I sette punti erano libertà di associazione, libertà di coscienza, difesa dell’insegnamento privato e della istruzione religiosa, opposizione al divorzio, parità delle organizzazioni economico-sociali, principi di giustizia nei rapporti sociali, far accrescere l’influenza dell’Italia nello sviluppare la civiltà internazionale. Nonostante che con l’enciclica Vehementer Nos (1906) il Papa avesse ribadito la posizione tradizionale (“che lo Stato debba essere separato dalla Chiesa, è una tesi assolutamente falsa, un errore molto pernicioso…”), i sette punti non mettevano in discussione né la Legge delle Guarentige né questioni scottanti (salvo il divorzio, che però non era maggioritario, tanto che, si è visto, il relativo progetto liberale, Zanardelli-Cocco Ortu, non era arrivato in porto).
Nella forma questi punti rientravano nella logica della separazione; oltretutto i parlamentari eletti avrebbero dovuto giurare fedeltà a quel Re che, per gli oltranzisti, restava il carceriere del Papa. Insomma non erano interpretabili come una politica concordata con la gerarchia. Quindi non c’era diretta contraddizione nel fatto che diversi candidati liberali si proponessero di seguire quei sette punti, anche perché si trattava di una libera scelta dei singoli candidati in chiave separatista. Semmai il pericolo era l’altro enunciato da Giolitti, “chi si obbliga ad una determinata politica non può essere considerato liberale”. In altre parole, il pericolo era che, seguendo tale strada, il voto finisse per dipendere da un contratto con gli elettori. Concetto che un liberale aborre (Giolitti vedeva lontano). Per un liberale il mandato implica il dovere di rispondere delle scelte parlamentari, che debbono essere fisiologicamente trasparenti e soggette a giudizio dell’elettorato, ma non emanazione pedissequa di un obbligo assunto per farsi votare (è uno spartiacque tra il parlamentarismo ed altre forme di rappresentanza).
I liberali sottovalutarono che l’UECI, pur intaccando l’applicazione formale del non expedit, non rinunciava in niente ai suoi presupposti politici di difesa della Chiesa. E di fatti presentava i sette punti come un baluardo cristiano e li chiamava Patto Gentiloni. Tale denominazione faceva pensare ad un accordo bilaterale sul pratico riconoscimento dell’impossibilità di prescindere dalle tesi religiose per gestire la cosa pubblica: stava proprio in questo il letale veleno antiseparatista. Ora, in verità il cosiddetto Patto Gentiloni non è mai stato quel riconoscimento e neanche un patto nel senso proprio del termine. È stato solo un abile accorgimento diplomatico unilaterale del mondo cattolico. Non c’è stato alcun patto firmato. Al candidato – sempre pronto a soddisfare l’elettore – è stato offerto di dichiararsi disponibile a programmi coerenti con il suo modo di pensare e non esclusivi dei cattolici. Poi si disse che ciò significava perseguire obiettivi conformi alla dottrina cattolica e in tal modo si giustificava la partecipazione dei cattolici alla vita politica.
4.2 b .2 d Le elezioni del 1913 e il governo Salandra I -Tuttavia l’ambiguità culturale era profonda. Trascorsi i mesi di ordinario svolgimento delle battaglie politiche (inclusi alcuni scioperi locali, dei marmisti, degli operai dell’auto a Milano e a Torino, dei metallurgici in varie città), il Patto Gentiloni manifestò la sua forza alle elezioni dell’ottobre 1913 (votanti il 61%). L’area liberale passò da 306 a 260 eletti, conservando di poco la maggioranza assoluta, ma moltissimi eletti avevano accettato i sette punti e così era stato stabilito un rapporto cardine con i veri e propri rappresentanti dei cattolici che erano cresciuti fino a 34. Inoltre, con l’allargamento elettorale, erano aumentati di un pò i vari deputati socialisti e radicali.
Il cosiddetto Patto Gentiloni poteva essere utilizzato dai fautori del principio di separazione perché nella forma non lo contrastava, ma dal punto di vista cattolico serviva all’obiettivo opposto. Serviva a combattere l’anticlericalismo socialista e al tempo stesso il separatismo liberale. I liberali sottovalutarono tale ambiguità. L’averla sottovalutata attivò un meccanismo che cambiò il quadro e nel tempo si rivelerà esiziale per il movimento liberale. Presero spazio coloro che esibivano la rappresentanza dei valori religiosi per ottenere i suffragi (questo corrodeva il separatismo) e che poi tendevano ad agire in proprio. Tutto ciò era la conseguenza dei sette punti voluta e apertamente dichiarata da Gentiloni: “è inutile dissertare sulla sovranità popolare che i cattolici non potrebbero mai ammettere nel senso proclamato dal liberalismo politico, perché ogni autorità è promossa da Dio e non dal popolo; cioè la sovranità non risiede essenzialmente ed inalienabilmente nel popolo”.
Dopo le elezioni, nei primi mesi della legislatura il nuovo quadro politico non dette rilevanti problemi al Governo, eppure Giolitti percepiva che, dopo tre anni, anche per il ripetersi di agitazioni di piazza, serpeggiava un certo logoramento. E così, essendosi i radicali ritirati dal Ministero a seguito della contrarietà ad alcune spese di guerra, Giolitti riprese il suo consolidato sistema e rassegnò le dimissioni, contestualmente consigliando al Re di nominare Presidente del Consiglio il conservatore Salandra e poi aiutandolo nella composizione del Ministero, che comprese i liberali di varie anime e l’UECI cattolica (21 marzo 1914). Da allora si verificarono in alcune città scioperi dei lavoratori, serrate degli armatori navali e poi, suscitate da forti tensioni a Trieste tra slavi ed italiani, manifestazioni studentesche di appoggio nazionale. Poi a giugno, sulle coste adriatiche, dalle Marche alla Romagna, scoppiarono movimenti di protesta molto accesi (vi furono morti), contro i quali vennero impiegati anche marinai sbarcati appositamente e a favore dei quali il PSI e la Confederazione Generale del Lavoro indissero uno sciopero nazionale che in sostanza non riuscì. A luglio la situazione pareva tornata alla normalità, sia sul versante della sinistra sia su quello della destra nazionalista.
4.2 b .2 e – La prima guerra mondiale e il neutralismo – Tuttavia, nei primi giorni del mese, si diffuse la drammatica notizia che il 28 giugno, in Bosnia a Sarajevo, uno studente serbo , nonostante gli avvisi dei servizi segreti, aveva ucciso l’Arciduca Francesco (insieme alla moglie) erede dell’Impero Austriaco. Drammatica al di là dell’immaginabile. L’Austria ritenne complice il governo serbo e volle cogliere l’occasione per tarparne le velleità espansive irrobustite dopo il successo nella guerra balcanica negli anni recenti. L’Austria godeva dell’appoggio della Germania, che aveva orami acquisito un rilevante peso economico e che non riteneva solida l’ Intesa del 1907 tra Francia, Russia ed Inghilterra. Anzi, pensava che la permanente questione irlandese avrebbe tenuto l’Inghilterra fuori dalla disputa con la Serbia. Così l’Austria intimò a Belgrado di sconfessare i maneggi irredentisti e di consentire alla stessa Austria un’indagine diretta in Serbia per reprimere i sediziosi. La risposta serba non soddisfò gli austriaci e, nonostante i tentativi inglesi e russi di calmare tedeschi ed austriaci che non ebbero esito, a fine luglio scoppiò la guerra tra Austria e Germania da una parte e Francia, Russia ed Inghilterra dall’altra.
Dell’ultimatum alla Serbia, il governo austriaco non aveva informato in anticipo l’Italia, violando così le norme della Triplice Alleanza tra Austria, Germania ed Italia. Il che comportava – è scritto nella comunicazione del 25 luglio all’ambasciatore tedesco a Roma in un colloquio con Salandra e San Giuliano – che “ilmodo di procedere dell’Austria, e per il carattere difensivo e conservatore della Triplice Alleanza, l’Italia non ha obbligo di venire in aiuto dell’Austria in caso che, per effetto di questo suo passo, essa si trovi poi in guerra con la Russia, poiché qualsiasi guerra europea è in questo caso, conseguenza di un atto di provocazione e di aggressione dell’Austria”. Insomma una presa di posizione che prendeva spunto dal Trattato della Triplice Alleanza per attuare la linea giolittiana dello star fuori dalle tensioni belliche su ampia scala, consapevole anche dell’impreparazione economica e militare. E che dopo due settimane portò a dichiarare la neutralità dell’Italia (atto su cui il paese si divise, tra gli interventisti – i nazionalisti, i radicali, l’ l’UECI , i futuristi – e i neutralisti – i giolittiani, tutti i socialisti e il nuovo Papa Benedetto XV – oltre i non pochi agnostici).
Nelle settimane successive, la diplomazia della Triplice e quella dell’Intesa cominciarono a premere ognuna perché l’Italia abbandonasse la neutralità e si schierasse al rispettivo fianco. Improvvisamente a metà ottobre morì (poco più che sessantenne) il Ministro degli Esteri San Giuliano , saldo neutralista, il quale aveva deciso (senza averne poi il tempo attuativo) fosse interesse italiano bloccare l’anarchia sorta in Albania sotto le pressioni contrapposte dei Serbi e dei Greci. In più a fine ottobre la Turchia entrò in guerra dalla parte della Triplice. Ciò implicava, per l’Italia, aumentare i fondi per rafforzare l’esercito (oltre 500 milioni) e questo indusse il ministro del Tesoro Rubini, neutralista, a dimettersi. Siccome nelle ultime settimane c’erano già stati avvicendamenti nella compagine ministeriale e del resto stava montando l’onda interventista, Salandra ritenne necessario un riassetto generale del Ministero, rassegnò le dimissioni. Riavuto immediatamente l’incarico il 2 novembre, Salandra fece alcune modifiche nella direzione di un minor rigido neutralismo , cominciando dal fare Ministro degli Esteri Sidney Sonnino, da anni il liberale meno giolittiano (anche se durante il suo secondo governo aveva nominato Senatore del Regno Benedetto Croce, che apprezzava molto Giolitti). La maggioranza parlamentare restò la stessa.
In Aula Salandra espresse in modo aperto le sue preoccupazioni sulla. neutralità. “Lo studio più scrupoloso della lettera e dello spirito degli accordi esistenti c’indussero nel sicuro e leale convincimento che non avevamo obbligo di prendervi parte. Tuttavia la neutralità, liberamente proclamata e lealmente osservata, non basta a garantirci dalle conseguenze dell’immane sconvolgimento, che si fa più ampio ogni giorno e il cui termine non è dato ad alcuno di prevedere….. non impotente, ma poderosamente armata e pronta ad ogni evento, doveva e dovrà” essere la neutralità nostra”. Una posizione confermata nella mozione finale. “La Camera, riconoscendo che la neutralità dell’Italia fu proclamata con pieno diritto e ponderato giudizio, confida che il Governo, conscio delle sue gravi responsabilità, saprà spiegare, nei modi e coni mezzi più adatti, un’azione conforme ai supremi interessi nazionali“.
4.2 b 2 f Verso il cambio dell’alleanza militare dell’Italia – Durante il mese di novembre e poi a dicembre e a gennaio, proseguirono serrati i contatti con la Germania e con l’Austria. L’obiettivo italiano era di ottenere il rispetto del Trattato istitutivo della Triplice Alleanza, e cioè il compenso territoriale per la modifica degli equilibri balcanici causata dall’occupazione austriaca della Serbia. E il compenso sarebbe dovuto essere di territori fino ad allora appartenuti all’Austria. Tuttavia, mentre i tedeschi si mantenevano dialoganti, gli austriaci rilanciavano tirando in ballo l’ulteriore modifica degli equilibri balcanici determinata dall’occupazione italiana del Dodecaneso e della città albanese di Valona, intervenute nel tardo autunno.
Nelle medesime settimane proseguiva il rapido espandersi anche organizzativo dell’associazione Fasci Interventisti. Ne era membro di spicco Benito Mussolini, ex direttore dell’Avanti uscito ad inizio autunno dal PSI, fondatore e direttore del Popolo d’Italia con il quale svolgeva un’intensa campagna di sostegno alla tesi “guerra, all’Austria e alla Germania”. Di fatti, a fine gennaio l’assemblea nazionale interventista votò la richiesta al Governo “dell’immediata, pubblica e solenne denuncia del Trattato della Triplice come inizio dell’azione autonoma dell’Italia nel conflitto internazionale”. Quanto ai cattolici impegnati in politica, dichiaravano che la loro neutralità non andava confusa con quella del Papa, poiché loro, nell’ambito della legge cristiana della civiltà, accettavano la dolorosa necessità della guerra. Da parte sua Giolitti, scrisse “considero la guerra non come una fortuna, ma come una disgrazia, la quale si deve affrontare solo quando sia necessario per i grandi interessi del Paese “.
In una simile atmosfera, i movimenti interventisti divenivano sempre più attivi ed esigenti, attraendo gruppi diversi, anche contrari alle manifestazioni di piazza. Il Governo, nel tentativo di abbassare il livello delle tensioni, vietò i pubblici comizi ma ottenne il solo risultato di forti critiche anche da parte socialista. I primi di marzo il Presidente del Consiglio incontrò Giolitti per fare il punto e per sondarlo sulla possibilità che accettasse di subentrare nella carica. Giolitti declinò tale possibilità poiché giudicava un ministero tendenzialmente interventista più adatto a farsi riconoscere dall’Austria alcune legittime compensazioni rispetto ad un ministero neutralista filotedesco (come sarebbe stato un Giolitti V). Giolitti confermò perciò il sostegno al Salandra 2 , dopodiché ripetè il suo modo abituale di comportarsi. Lasciò Roma per far ritorno nei suoi possedimenti piemontesi, in attesa.
Nelle quattro cinque settimane seguenti, accelerò la presa degli slogans dei Fasci Interventisti (anche con nuovi scontri in piazza). I quali trovavano una sorta di corrispondenza nel frenetico assestamento interno alle organizzazioni militari e che, in più, sventolavano crescentemente la bandiera del Risorgimento da completare, anche con l’appoggio della massoneria. Contestualmente proseguivano a livello riservato i continui contatti diplomatici tra Italia ed Austria (ma pure con la Germania) nel tentativo di trovare una soluzione alle richieste italiane fondate sull’art.7 della Triplice Alleanza. Peraltro era una trattativa assai impantanata che non lasciava intravedere sbocchi positivi, nonostante le insistenze della Germania perché l’Austria si ammorbidisse sulle richieste italiane.
4.2 b 2 g Il Patto di Londra e l’entrata in guerra – Peraltro, osservando le cose retrospettivamente, qui è indispensabile inserire la citazione di una serie di eventi di cui all’epoca, salvo le singole persone coinvolte, nessuno sapeva niente e che, anche a livello parlamentare, diverranno noti solo anni dopo, alla fine della guerra. Va messo in evidenza che i primi di marzo il Ministro degli Esteri aveva incaricato l’ambasciatore a Londra di comunicare per scritto al Governo inglese che l’Italia era disposta a schierarsi con la Triplice Intesa entro il 25 maggio, in base a precise condizioni. Nessuna pace od armistizio separati di Francia, Inghilterra, Russia e Italia; la Russia avrebbe dovuto continuare la guerra contro l’Austria-Ungheria; consegna all’Italia del Trentino di Trieste e dell’Istria, di gran parte della Dalmazia con tutte le isole a nord e ad est, l’isola di Saseno, il Dodecaneso; inoltre compensi in Africa all’Italia nelle colonie tedesche conquistate dall’Intesa, compensi in Turchia se l’impero ottomano fosse stato diviso, diritto dell’Italia di occupare Adalia e il territorio intorno se fosse stata occupata l’Asia Minore; la Santa Sede sarebbe stata esclusa dai negoziati di pace. Tali condizioni, dopo una trattativa durata poco più di un mese con i paesi dell’Intesa, vennero per larga parte accolte e alla fine il 26 aprile 1915 gli ambasciatori in Inghilterra dei quattro paesi firmarono il Patto di Londra, unitamente ad alcune dichiarazioni connesse, fissandone anche la relativa segretezza fino ad una successiva sottoscrizione da parte dei quattro Stati.
Tornando agli avvenimenti allora pubblici, va detto che nel frattempo le trattative tra l’Austria, la Germania e l’Italia si erano sempre più arenate per l’evidente atteggiamento dilatorio degli austriaci ostili a concludere. Finché il 3 maggio Sonnino fece consegnare dall’Ambasciatore a Vienna una comunicazione che si concludeva così “Perciò l’Italia, fidando nel suo buon diritto, afferma e proclama di riprendere da questo momento la sua intera libertà d’azione e dichiara annullato e ormai senza effetto il suo trattato d’alleanza con l’Austria- Ungheria”. La notizia della comunicazione dette nuovo impulso agli interventisti, impegnati in quelle ore a Quarto nelle celebrazioni garibaldine per l’inaugurazione del monumento ai Mille. Una manifestazione assai ampia cui intervenne D’Annunzio (rientrato apposta dopo cinque anni dall’esilio autoimpostosi in Francia per sfuggire ai debiti fiscali), che pronunziò un lungo discorso infiammato in cui elencò i segni della grande vigilia del ritorno ai grandi eroi della patria in armi.
Finalmente il 7 maggio il Consiglio dei Ministri veniva informato che l’Italia si era impegnata ad entrare in guerra a fianco dell’Intesa entro il 25 maggio. Il Consiglio, dopo un lungo dibattito, approvò e s’impegnò alle dimissioni se la Camera lo avesse bocciato. Il giorno successivo, il Re fece sapere che avrebbe abdicato in caso di un voto contrario alla Camera. Nella stampa si erano formati schieramenti netti. Sostenevano gli interventisti il Corriere della Sera, il Secolo, il Popolo d’Italia di Mussolini, l’Idea Nazionale del vice presidente Fiat, il Mezzogiorno, la riformista Azione socialista, l’Idea democratica, l’Asino anticlericale; sostenevano la linea .ministeriale e di attesa il Giornale d’Italia e la Nuova Antologia; erano giolittiani soprattutto La Tribuna e La Stampa; neutralisti, il Popolo Romano, l’Avanti !, l’Osservatore romano, l’Unità Cattolica, il Mulo, il Bastone. Nelle grandi città iniziarono contrapposte manifestazioni di irredentisti e di pacifisti.
Giolitti, che ignorava l’esistenza del Patto di Londra e dava un giudizio negativo sull’abbandono della Triplice Alleanza, tornò a Roma fatto oggetto di contestazioni durante il viaggio. Il giorno 9 fu convocato da Re, al quale argomentò la contrarietà alla guerra, specificando che dello stesso avviso era la maggior parte degli italiani e di sicuro la Camera. A richiesta confermò che Salandra sarebbe dovuto restare al suo posto finché avesse avuto la fiducia del Parlamento. Nel pomeriggio Giolitti fu invitato a recarsi a casa Salandra ove venne informato delle ultime offerte austriache. Risulta da un articolo dell’epoca sul Giornale d’Italia che il colloquio fu approfondito ma non fece mutare le rispettive opinioni. Giolitti riconobbe la portata degli argomenti di Salandra ma restò dichiaratamente nella sua opinione, perché al disopra di ogni argomentazione di Salandra, “ha sempre creduto, e crede, che la guerra sia un grave pericolo date le condizioni del Paese e possa trasformarsi in un danno anche riuscendo vittoriosa“.
Nei tre giorni seguenti, i plenipotenziari austriaci e tedeschi presentarono al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri ulteriori proposte più attente alle richieste dell’Italia. Tuttavia erano proposte tardive e neppure di immediata applicazione, per cui il Consiglio dei Ministri le respinse definitivamente e al contempo confermò la sua scelta avversa alla neutralità. Questa linea aveva il supporto accanito della galassia interventista. A Milano si manifestava contro la sede del Corriere della Sera, con le arringhe di Mussolini, direttore del Popolo d’Italia, all’insegna dello slogan “Viva la guerra liberatrice”. A Roma l’assemblea cittadina di tutti gli interventisti riunita nella sede dei Socialisti Riformisti votò una mozione in cui “si dichiara Giovanni Giolitti complice dello straniero e nemico della Patria” e si evoca “la passione dei padri con la nuova guerra liberatrice e redentrice dei figli“. A questa mozione Giolitti reagì con una lettera al direttore della Tribuna, Olindo Malagodi, in cui rilevava che ”neppure, di mia iniziativa, ma chiamato, ho espresso un’opinione conforme alle mie convinzioni e coerente con le opinioni già manifestate e in un discorso parlamentare e nella pubblica stampa. È inesplicabile come partiti che professano principi di ampia libertà abbiamo così poco rispetto per le opinioni altrui”.
Giolitti esprimeva concetti chiarissimi e realistici ma si riferiva ad interlocutori indisponibili al riflettere in modo critico, che è invece la base solida del convivere. La riprova venne prestissimo. Per manifestare la loro solidarietà di fronte agli attacchi, più di 300 deputati consegnarono in poche ore i rispettivi biglietti da visita nella casa di Roma dell’on. Giolitti. Di conseguenza, il Governo Salandra rassegnò le dimissioni. Nel contempo il quotidiano l’Idea Nazionale” rincarava la dose con un articolo di fondo titolato “Il Parlamento contro l’Italia”in cui sosteneva che “II Parlamento è Giolitti; Giolitti è il Parlamento: il binomio della nostra vergogna. … il Parlamento è la falsificazione della Nazione. 0 il Parlamento abbatterà la Nazione, o la Nazione rovescerà il Parlamento”. Il Re, su consiglio di Giolitti, cercò di incaricare il Presidente della Camera oppure il Ministro del Tesoro, dato che Giolitti stesso giudicava errato passare da un governo interventista ad un governo dichiaratamente neutralista (in quanto avrebbe irrigidito maggiormente Austria e Germania, mentre i deputati indicati erano neutralisti ma in grado di trattare in modo più duttile e realistico). Essendosi i due deputati detti indisponibili, il Re scelse la strada di cui era personalmente convinto, quella di completare il Risorgimento. E così il 16 maggio respinse le dimissioni di Salandra. Decisione esaltata da Mussolini sul Popolo d’Italia e da D’Annunzio a Roma,
Nella sostanza, in quel momento la determinazione del Re (soprattutto) e di Salandra divenne fermissima, specie nel sostenere l’azione di Sonnino. Al punto che pure i moti di piazza contro il neutralismo giolittiano crebbero a dismisura e si arrivò all’irruzione della folla dentro Montecitorio senza che ci fosse una reale difesa da parte della forza pubblica né una presa di posizione del Governo. Il Ministro degli Esteri, con indubbia abilità, alla vigilia del dibattito in aula, presentò un Libro Verde in cui erano esibite le carte diplomatiche degli ultimi mesi, presentate in modo da nascondere i termini del Patto di Londra (ed anche il tentativo austriaco in extremis di fare concessioni) e da limitarsi a sostenere l’inevitabilità dell’entrata in guerra contro l’Austria Ungheria, per il momento non Turchia e Germania. Proposta decisiva , per forza da presentare alla Camera, poiché l’entrata in guerra richiedeva l’autorizzazione. Insieme alla parola d‘ordine “completare il Risorgimento”, al Parlamento non venne detta l’intera verità sul come stavano le cose. In questo quadro la Camera dette la richiesta autorizzazione per la guerra all’Austria Ungheria. E così, senza dirlo, fu rispettato l’impegno del Patto di Londra di entrare in guerra a fianco dell’Intesa entro il 25 maggio.
Fatto sta che, dopo la consegna dei biglietti da visita dei deputati, Giolitti non fece più atti politici ritenendo impossibile bloccare in Parlamento la tenaglia tra la Corona e la piazza senza provocare una gravissima crisi nell’equilibrio del Regno. Oggi, dopo oltre un secolo, è del tutto inutile interrogarsi se il giudizio di Giolitti fosse allora realistico o meno. Certo è che la decisione di entrare in guerra costituì il punto di svolta in Italia per l’avvio della stagione – che sarebbe durata decenni con aspetti tragici – in cui il Parlamento venne ritenuto non più rappresentativo del paese reale. Si iniziò ad uscire dalla linea liberale di Cavour, per il quale “la via parlamentare era più lunga, ma la più sicura”. Il Parlamento veniva dopo la complessiva primazia del Re e in subordine del Governo. Al tempo stesso, i giornali inclinavano a gonfiare le opinioni dei cittadini più che ad informarli sulle materie da decidere. Ed iniziarono a manifestarsi gli effetti dell’artificio cattolico del cosiddetto Patto Gentiloni. Tale svolta ha dato un valore profetico alla considerazione di Giolitti menzionata sopra. “La guerra potràtrasformarsi in un danno anche riuscendo vittoriosa”. Questi sono gli esiti alla lunga disastrosi dell’adottare l’antica pratica di far decidere la convivenza ai potenti, ritenendoli i soli capaci di capire l’interesse della nazione.