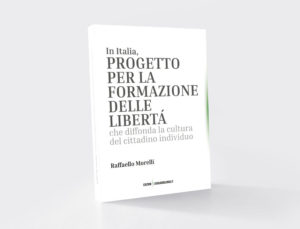Premetto che rispondo alle tre domande di Caffeeuropa sulle prospettive del Partito Democratico, perché sono stato personalmente interrogato, non perché condivida il progetto PD, al quale come liberali siamo contrari da lungo tempo e con fermezza. Lo faccio però con molto piacere, siccome Caffeeuropa è un’arena rilevante e la questione in sé resta comunque centrale nella politica italiana.
La mia risposta alla prima domanda, quella sulla credibilità, è che progetto e gruppo dirigente sono strettamente connessi. Nel senso che il progetto discende da quello costruito dal gruppo dirigente fin dall’inverno 1995-1996 e il gruppo dirigente è in sostanza lo stesso di quell’inverno. Dunque è normale che si reggano e cadano insieme. Questa linea non diverrebbe più credibile con un altro gruppo dirigente e questo gruppo dirigente non diverrebbe più credibile con una politica differente.
La linea non diverrebbe più credibile perché il suo difetto sta nel dna, che è l’idea dell’ulivismo. In origine Ulivo e ulivismo non erano la stessa cosa. L’Ulivo era la coalizione che aveva preso corpo a partire dalla primavera 1995 come coalizione politica alternativa alla proposta della Casa della Libertà vincitrice delle elezioni 1994 (e come liberali abbiamo fatto parte dell’Ulivo fin dal tavolo fondante nel giugno 1995). L’ulivismo era invece il sottostante disegno di Prodi e Parisi i quali hanno sempre concepito il contrapporsi a Berlusconi come base per sviluppare nel tempo una formazione unica che organizzasse stabilmente tutto il centrosinistra all’ interno di uno schema bipolare e comprimesse il solo gruppo esterno al grande Ulivo, Rifondazione. Noi liberali fummo tra i pochi ad avvertire da subito questa pretesa di trasformare la coalizione dell’Ulivo in ulivismo ( con una cultura politica per forza di cose indistinta) e perciò , dopo il seminario di Gargonza concepito come culla del nuovo amalgama (primavera ’97), progressivamente ci distaccammo pur rimanendo sempre con il centro sinistra, nonostante le lusinghe.
Ritenevamo allora e continuiamo a ritenere oggi, che sia assurdo volere dare risposte al problema di come organizzare la convivenza (vale a dire governare) basandosi sull’indistinzione culturale. E questo perché, almeno per noi liberali, organizzare la convivenza significa rendere sempre più forte la capacità di ogni cittadino di essere individualmente libero e di poter esercitare questa sua libertà nella concreta complessità delle cose. In tal caso, occorre avere più distinzioni culturali e non meno, perché solo disponendo di un più ampio ventaglio di valutazioni diversificate si può poi cogliere di tempo in tempo i nodi di illibertà da sciogliere e come riuscire a farlo. Per questo, specie nella tradizione italiana, sono indispensabili i diversi partiti (soprattutto corrispondenti ai filoni culturali ) e le coalizioni di partiti riunite su programmi di governo che indichino quali nodi affrontare e come farlo.
In ogni caso, l’idea ulivista ha continuato a muoversi nella cornice della indistinzione quale panacea , seppure in modo un pò carsico, e ha continuato dopo il rilancio (estate 2003) attraverso il PD, tentando magari ingannevoli colpi di mano, come il tentativo di gabellare i partecipanti alle primarie dell’Unione (autunno 2005) in aderenti all’ulivismo. Solo che oggi la situazione è ancor più difficile. Il PD è sì nato ma – secondo noi non poteva che essere così – è tuttora privo di un dichiarato e distinguibile progetto politico culturale che non sia il progetto PD stesso, inteso come promessa autoreferenziale di assicurare tempi migliori solo per il fatto di esistere. Così l’indistinzione culturale ulivista, un assurdo politico in partenza, ha assunto la forma di PD come sindacato di potere senza progetto di governo. E mancando un progetto politico culturale per affrontare la realtà dei problemi e districarla, si è cominciato a ricorrere ad una serie di diagnosi sostitutive del tutto insufficienti se non errate ( e talvolta intrinsecamente pericolose) che giustifichino l’esistenza del PD e motivino la evidente difficoltà di governare. Sugli esempi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Elenchiamone qualcuno abbastanza significativo ( senza dar particolare valore all’ordine espositivo) .
Cominciamo dall’ossessione di Procuste: se la realtà non corrisponde ai desideri, si taglia la realtà. Un primo caso è l’aspirazione dei dirigenti PD ad incarnare, in quanto presunto processo storico, il destino mondiale di nuovi assetti politici. Purtroppo per loro non ve ne è traccia neppure al livello più vicino per cultura e sociologia, quello europeo. Qui esistono ben radicati popolari, socialisti, liberali e più piccoli la sinistra, gli ambientalisti, la destra rigida. Nessuno dei tre più consistenti (neppure i socialisti più volte sollecitati da Fassino e Veltroni né i liberali che Rutelli ha tentato invano di corteggiare dal 2004) pensa neppur lontanamente a modificare la propria natura in direzione dell’indistinzione culturale del PD. La cosa singolare però è che il PD continua a negare scandalizzato che ognuna delle sue componenti possa restare in Europa nella sua collocazione di origine (socialisti con socialisti e ex-margherita con i Democratici Europei che in parlamento, con 22 deputati, hanno fatto gruppo con i liberali, 68 deputati) ma non dice mai quale sia il disegno alternativo. Siamo all’affabulazione utopica in difesa dell’annunciato ineludibile destino.
Poi c’è il caso della frammentazione. I partiti dell’Unione esterni all’Ulivo sono oggi numerosi, irriducibili ed elettoralmente ben più di un terzo della coalizione Unione. E siccome secondo tutti i sondaggi professionali la nascita del PD ha ulteriormente indebolito l’area PD, la tesi dei dirigenti PD è che questo avviene non perché il PD è oggettivamente percepito come un’arroccamento di potere bensì perché i partiti sono troppi. E dunque la cura non sarebbe definire proposte credibili per affrontare i problemi, ma impedire che i partiti siano tanti e cacciare i piccoli. Perciò si oscilla (ufficiosamente perché neppure qui esistono decisioni organiche ) da proposte per dare colossali premi di maggioranza (intorno al 25%) alla lista che arriva prima fino a proposte per introdurre soglie molto alte ( intorno al 12%) di accesso agli eletti, e , anche quando si rispolvera il maggioritario a doppio turno di collegio (la storica proposta dei liberali fin dai primi anni ’90), si fa in modo così approssimativo da renderlo incomprensibile. Tutto ciò non spinge verso il ritorno alla politica, con proposte, conflitti sulle proposte, scelte e controlli più consapevoli. Serve per tentare di congelare l’esistente attorno ai partiti più grossi. E tanto per non lasciare equivoci, Veltroni ha ripetutamente teorizzato che “tre senatori che si mettono insieme per minacciare il governo di farlo cadere è un’alterazione del meccanismo della democrazia”. Ora, negare le ragioni di ciascun eletto equivale a negare i fondamenti secolari della cultura parlamentare liberale e insieme corrisponde alla volontà di eludere la centralità del cittadino e il confronto su proposte e risultati per consentire il contributo vero di ciascun filone politico culturale. Insomma, in questi termini la lotta alla frammentazione e la caccia ai piccoli sono solo un inno al conformismo di potere dei grossi senz’anima civica seria. Non è la frammentazione che rende difficile la governabilità, è la grave carenza di progetto politico che incentiva la frammentazione.
Dopo Procuste, posso proseguire con la preoccupante assonanza tra prassi del PD e di FI quanto a procedure di decisione interne. Ambedue leaderistiche e plebiscitarie. Ormai anche Berlusconi convoca i gazebo e anche Veltroni estrae di tasca le decisioni motu proprio. E’ una conseguenza del rifiutare il concetto stesso di politica come conflitto secondo le regole tra culture, idee e proposte. Si procede per rituali. Si redigono programmi preelettorali e puntualmente non si rispettano; è avvenuto nella legislatura passata e sta accadendo in questa. Se il governo non riesce a governare, prima era colpa dei filo statalisti conniventi sottobanco con la sinistra, oggi è colpa degli eccessi della sinistra antagonista. Non era vero prima e non lo è oggi. Oggi ci si comporta come se i problemi sollevati dalla sinistra antagonista coincidessero con le sue proposte, mentre le due questioni sono ben distinte. I problemi sollevati sono molto spesso reali ( vedi questione salari bassi e vedi questione della sdrucita rete di protezione sociale ) , le soluzioni avanzate spesso vetero ideologiche. Allora si dovrebbero affrontare i problemi. Ma non si affrontano per non uscire dalle contrapposizioni tradizionali che sono rispettivamente utili ai soliti interessi e bacini di consenso. Cioè si vuol restare alla politica come promessa e non arrivare alla politica come proposta, si vuol restare alla politica come millenarismo miracoloso e non arrivare alla politica come costruzione. Nonostante le giaculatorie in senso contrario, la convinzione profonda è che i veri politici devono essere furbetti di palazzo, pensare ad esercitare il potere e non a progettare.
Bosetti si chiede se alcune affermazioni del Manifesto del PD non suonino addirittura comiche oppure siano un oltraggio al senso comune. A me pare che sia una domanda che esprime con chiarezza un forte sconcerto ma che non va al cuore del problema. Ciò che accade non è un deprecabile incidente ma l’obbligata conseguenza delle scelte che ho prima descritte. Come ho argomentato, per questo progetto e per questo gruppo dirigente il parametro di riferimento non è la realtà ma la realtà confacente ai propri interessi (di potere). Per cui si scrive che bisogna reagire allo scadimento della proposta televisiva e innovare il servizio pubblico, e poi motu proprio si nomina responsabile delle politiche di comunicazione e informazione del PD il sen. Follini, che ha rappresentato il partito RAI già da metà degli anni ’80 per quasi un decennio. Insomma, occorre convincersi che la non credibilità politica dell’attuale gruppo dirigente PD non è questione di incapacità gestionale ed attuativa del progetto politico, attiene alla scelta del progetto e al delineare la strategia politica di fondo. E’ l’ispirazione generale del disegno PD a essere inadeguata rispetto ai bisogni della società italiana. Il gruppo dirigente PD non è un gruppo di incapaci. Ha solo la colpa politica di aver fatto questa scelta e di averla sostenuta pervicacemente per un decennio.
Questo particolare tipo di cultura ha purtroppo dilagato nell’habitat di centro sinistra. Lo conferma l’apertura del commento della Ambrosi con due interrogativi che di quella cultura sono figli: se al PD serva davvero una “carta dei valori” e, se sì, quale delicata alchimia vada cercata nella formulazione di punti più che controversi. Ai due segue poi un terzo interrogativo-figlio: se una carta dei valori possa bastare a dirimere le controversie di un partito “post-ideologico”. A questi tre interrogativi, una cultura di tipo liberale fornisce tre evidenti risposte. Che un partito senza carta dei valori può essere solo un partito di potere ( a meno che non voglia ridursi a gruppo di pressione tematico ). Che le alchimie servono nei laboratori chimici (ove la diversità dei rapporti tra i componenti determina la diversità della molecola) ma non servono per formulare carte dei valori (ove la chiarezza dei concetti non dipende dalle parole adoperate quanto dalle relazioni tra le idee che li individuano). Che, se il partito è postideologico ( includendo l’ideologia di mero potere), la carta dei valori dirime le controversie sull’identità culturale del partito in quanto la definisce.
Di nuovo, la difficoltà di definire cosa sia il PD deriva non da suoi dirigenti poco credibili ma dalle impostazioni profonde dei due partiti chiesa dai quali in massima parte proviene. Impostazioni che portano ancora a respingere istintivamente l’idea che la democrazia sia conflitto tra individui singoli e associati entro regole predeterminate e aggiustabili nel tempo per rapportarsi al reale. Prima la mentalità dominante era che l’esistenza stessa di ciascuno derivava dallo stare nella propria chiesa; ora che la chiesa è una sola, questo si traduce nell’ossessione dell’inclusività (l’ormai famoso “ma anche” del comico Crozza) di tutti nella chiesa comune. E l’eccessiva inclusività , ricorda giustamente Ambrosi, diventa un ostacolo peggiore del settarismo quando pretende di mettere insieme posizioni radicalmente eterogenee. Per questo scatta il placebo della profezia rassicurante, essere indistinti sarebbe la storia in marcia.
Per di più, nel PD il criterio dell’indistinzione delle culture e delle identità si miscela in modo potenzialmente esplosivo con l’idea di partito fluido. Perché la fluidità è la tipica conseguenza dell’esistenza di un coacervo di particelle distinte che scorrono l’una sull’altra secondo proprie traiettorie. E nel caso di cittadini, il fluire senza una qualche prima forma di aggregazione per identità politica (i filoni culturali) che consenta un confronto chiaro tra approcci differenti e sui risultati che possono dare, porta a non avviare un dibattito vero e approfondito ma solo a dibattiti caricaturali, confusi, vuoti di contenuti e prodromici appunto alla demagogia leaderistica che si sovrappone alla libertà di ciascuno.
Io penso che il limite essenziale del PD consista nella attitudine gattopardesca che ha portato alla sua nascita. Si è puntato il dito contro le ideologie annunciando l’avvento della indistinzione culturale, che non coglie il senso della crisi delle ideologie epperò, avendone dichiarata la fine, permette di non perdere gli agganci pratici e le abitudini delle vecchie militanze. Basti qui dire che il senso della crisi delle ideologie non sta nella fine della storia. Sta nell’aprirsi al senso del tempo e della libertà individuale, della costruzione che subentra all’utopia, della scoperta della enorme variabilità delle identità degli individui e negli individui. Invece negli ambienti del PD si continua a far confusione tra criteri per collaborare e coalizzarsi che sono una cosa e criteri di identità che sono un’altra. Non si devono sovrapporre. I primi richiedono la preesistenza dei secondi ma non derivano necessariamente da loro. Anzi, anche collaborare e coalizzarsi non prescindono dal conflitto secondo le regole e sono un processo progressivo dall’esito non predeterminato. Importante è risolvere i conflitti che si manifestano, non ( illudersi di ) impedire ogni conflitto. In una democrazia, non possono crearsi partiti democratici per forza e in un attimo; è già difficile farlo per le coalizioni. Anche la sbandierata vocazione maggioritaria non caratterizza politicamente, dato che ogni partito vorrebbe esserlo. Né è caratterizzante l’essere grosso numericamente. Anche qui c’è stata la corsa ad un equivoco grave, vale a dire che l’obiettivo del maggioritario fosse il bipolarismo quando invece era mettere i cittadini in condizione di scegliere gli indirizzi di governo e poi di dare il giudizio sul come il governo era stato gestito. E dunque le coalizioni non dovrebbero essere costruite contro qualcuno ma per governare. E’ stato l’aver scelto – in rigorosa convergenza bipartisan – la strada delle “coalizioni contro” (chiaro retaggio dei partiti ideologici) che ha posto le premesse dell’impotenza decisionale.
A me pare che da qualunque parte si esamini la questione, vien sempre fuori che l’indistinzione corrisponde ad un modo di concepire la politica come battaglia tra gruppi di potere più o meno chiusi , che non ha e non può avere in cima ai suoi pensieri il cittadino alle prese con i suoi problemi di vita quotidiana. Questo stato di cose si riflette su ogni argomento. Ad esempio sul tema della laicità ( la terza domanda di Caffeeuropa). Non per caso Ceruti, stendendo la bozza del Manifesto dei Valori del PD, ha posto al cuore della laicità PD il riconoscimento della rilevanza delle religioni nella sfera pubblica, non solo in quella privata. Perché dare questo riconoscimento significa aggirare la dimensione individuale e perciò rinunciare alla laicità delle istituzioni. Di fatti, la formulazione Ceruti non punta certo a sostenere che è rilevante la libertà di esternare in pubblico il proprio credo ( Odifreddi, che della stessa Commissione farebbe parte, ha sostenuto questa libertà ed è stato assalito da tutti i clericali) bensì punta sostanzialmente a sostenere che è rilevante riconoscere alle organizzazioni religiose uno status privilegiato nella formazione delle leggi su materie decisive per formare e consentire ad ogni cittadino di esprimere la propria variegata identità. I clericali fanno come se queste due accezioni di rilevanza coincidessero, mentre per i laici esse sono mutuamente esclusive. Nessun vero laico ha mai voluto eliminare la religione o trattato come avversarie le Chiese limitando l’esercizio della religiosità. Gli avversari politici dei laici sono coloro che, non appartenendo alle strutture religiose, propugnano in qualche modo la fede come fonte politico legislativa. Su questo si impernia l’essenziale ragion d’essere politica dei laici, perché costituisce uno degli aspetti cardine della centralità del cittadino.
E invece l’ossessione dell’includere spinge Veltroni ad accettare il dialogo con Ferrara, quasi non capisse che Ferrara non reclama affatto il fisiologico adeguamento della legge sull’aborto al progresso scientifico degli ultimi trenta anni. La crociata di Ferrara reclama apertamente la moratoria della legge in nome della accettazione legislativa della tesi religiosa secondo cui al momento del congiungimento sessuale nasce l’individuo. E’ l’avvio di una felpata abrogazione che appunto farebbe regredire la libertà responsabile del cittadino, in particolare quella della donna. Ed è davvero singolare che, mentre tra i cittadini italiani i comportamenti laici stanno crescendo sensibilmente, il mondo politico più “grosso” ( PD e FI ) si pieghi sempre più alle pressioni di minoranze religiose che si avvantaggiano di una loro maggior spregiudicata determinazione per manovrare in un clima sganciato dalle idee e dunque più conformista.
Ambrosi richiama il giusto interrogativo che ha posto Chiara Saraceno ( “Ma se negli anni Settanta ci fosse stato il Partito democratico, avremmo avuto leggi come aborto, divorzio e riforma del diritto familiare ?”) e afferma che la risposta “sì”, purtroppo, non è scontata. Con un pizzico di malignità si potrebbe osservare che di fatti nelle battaglie di allora, quanto meno su divorzio e aborto, l’indiscussa leadership non fù dei gruppi che sono l’odierna ossatura del PD ma fù dei gruppi laici tradizionali con a rimorchio un PCI recalcitrante ( nel ’74 la chiusura del referendum sul divorzio venne fatta in due comizi distinti, festante quello Piazza del Popolo di tutti i laici, funereo quello di Piazza S.Giovanni del PCI) e con i dirigenti del mondo cattolico, eccetto il diritto di famiglia, assenti salvo numericamente poche eccezioni. Ma anche senza cedere a maligne notazioni, credo non si possa non vedere l’amara realtà alla radice. Che accettando di scivolare nella politica come indistinzione e come puro evento mediatico, la battaglia al berlusconismo diviene di giorno in giorno – e ben oltre la contingenza del dialogo tra maggioranza ed opposizione – un pura declamazione. Abbiamo il coraggio di riconoscere che, con l’involuzione politica della sinistra normale (quella di governo), purtroppo la Casa della Libertà sta vincendo la battaglia più importante, quella di imporre nella società italiana certi valori tipicamente illiberali , quelli del conservatorismo furbescamente bigotto e del successo senza meriti come orizzonte individuale.