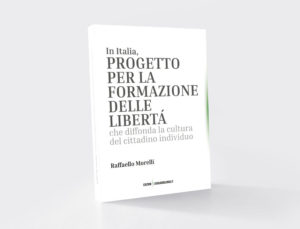desidero ringraziare gli Amici della Fondazione Einaudi di Roma, in particolare Enrico Morbelli, nonché la Agorà Liberale di Pasquale Dante, il Movimento Pensiero Liberale di Claudio Ferrante e il prof. Agostino Portanova, per iniziare la Scuola di Liberalismo con una lezione su questo tema che giudico essenziale, non in chiave storica ma per la vita quotidiana, oggi e in prospettiva: la separazione Stato religioni. Che non è amarcord anacronistico ma una condizione di vita sempre più attuale.
Questo principio è innanzitutto un richiamo esplicito alla politica vera, costruita sui progetti e non sulle apparenze. Se si punta al cambiamento sono ineludibili l’attenzione ai fatti e la sovranità del cittadino. E per costruire istituzioni adeguate al libero convivere, il nocciolo è non cedere mai sulle procedure coerenti ai principi e sull’esercitare il senso critico. Con tale impostazione, in Italia, la politica di separazione Stato religioni venne avviata dal Libera Chiesa in Libero Stato di Cavour lungo la linea culturale che risaliva a Locke, alla rivoluzione americana, a Tocqueville, alle ascendenze ginevrine della madre. Cavour intendeva fare l’unità senza cedere sulla libertà, e perciò non esitò a battersi contro il potere temporale ed i suoi privilegi. Oggi, per risollevare il paese da strutture farraginose che la crisi mondiale e l’inadeguatezza della politica di maggioranza e di opposizione ante tecnici hanno messo a nudo, è indispensabile rimodellare le istituzioni sulla sovranità dei cittadini individui, più esattamente puntando a riorganizzare la convivenza tra cittadini diversi per renderla più aperta e meno ingabbiata da autorità e da burocrazie.
In realtà, la spinosa questione dei rapporti tra Stato e religioni esprime l’eterna battaglia, come diceva Cavour, tra libertà del cittadino ed autorità sul cittadino. E proprio dall’avere il sogno del conformistico bene comune stabilito da qualcuno o qualcosa, deriva la repulsa di molti verso l’affidarsi, per convivere e per conoscere, al cittadino nella sua individuale irripetibile diversità e sul suo senso critico. Nonostante che l’esperienza storica abbia mostrato che il separatismo è l’unico sistema adatto ad inquadrare la diversità nella convivenza tra cittadini e di conseguenza a produrre un maggior grado di libertà e di benessere materiale.
La chiave del principio di separazione Stato religioni è non proporre una identità unica e non voler far prevalere una convinzione specifica. Serve a porre i presupposti per usufruire dello spirito critico di ognuno, secondo un metodo essenziale: non dubitare di
tutto e non credere a tutto. Solo così si può evolvere nel tempo della vita e cogliere la ricchezza della diversità non solo a parole.
Il separatismo ha due caratteri essenziali. Il primo, è garantire la piena libertà di religione di ciascun cittadino. Piena libertà di religione che applica la tolleranza intimamente connaturata con la laicità e con la convivenza tra diversi individui, i quali sono individui perché ben consapevoli dell’esistenza degli altri. Nella convivenza quotidiana, stare insieme non vuol dire per forza essere identici o appartenere alla medesima comunità. Stare insieme tra diversi significa accettare la comune prova dei fatti e tessere le rispettive relazioni condividendo le regole pubbliche.
Il secondo carattere del separatismo è la neutralità istituzionale in materia religiosa. E’ un aspetto essenziale per amalgamare le differenti convinzioni religiose, tutte con uguale dignità ed uguali diritti. Sul punto, i conservatori cattolici avanzano al Risorgimento accuse che non stanno in piedi. Perché la laicità istituzionale non ha mai escluso e non esclude i non laici. All’epoca del Libera Chiesa in Libero Stato, fu il Papato a rifiutare il principio e la legge delle Guarentige. Oggi la respingono quelli che, pur di respingere il separatismo, si inventano sofismi che, come il silenzio, si dissolvono appena se ne parla.
Ad esempio, affermano che è impossibile separare in ciascuna persona gli aspetti civili da quelli religiosi, e che sarebbe sufficiente distinguerli. Solo che il principio di separazione non riguarda i rapporti del singolo individuo con sé stesso bensì la convivenza tra molti individui differenti per identità religiosa. E quindi, la realtà pratica è esattamente al contrario. La separazione nel pubblico garantisce la distinzione nel privato, mentre limitarsi alla distinzione nel pubblico crea inevitabilmente il problema della doppia sovranità, vale a dire della fedeltà congiunta del cittadino a Stato e Chiesa.
Un altro esempio è la questione dell’etica. Per non andare alle lunghe e prendendo come esempio un libro di queste settimane dell’on. Binetti, impegnata nell’Opus Dei e in Parlamento, l’etica della religione cattolica è proprio di un altro genere, che non ha connessione con il separatismo, perché ruota intorno al circoscrivere la libertà individuale come metodo di vita personale e di decisione politica nella convivenza. L’etica cattolica, negli scritti del Papa ripresi espressamente dall’on. Binetti, è legata indissolubilmente alla fede. Il suo immutabile filo logico è verità-creazione-libertà come riconoscimento della verità. Questo la rende un’etica perenne per struttura. Che non ha spazio né per la libertà della diversità individuale nel rapportarsi ai fatti del mondo né per comprendere il tempo che pervade le cose e veicola il cambiamento.
Non per caso questa etica religiosa si traduce nel predicare la necessità di sottoporsi alla legge naturale supposta valida per tutti e per sempre. La legge naturale costituisce un concetto profondamente ambiguo dal punto di vista della separazione. Perché in
2
apparenza sembra riferirsi solo all’esistenza di una realtà esterna all’essere umano. Ma dietro questa ovvia considerazione, serve ad imporre la conoscenza di quella realtà nei termini della rivelazione divina e della conseguente legge stabilita da chi ne è il rappresentante in terra, la cosiddetta legge natuarle. Adottare la legge naturale supposta valida per tutti porta prima ad accettare l’omogeneità di ogni civiltà in ogni tempo e a vincolare la differenza individuale nel decidere la propria vita e poi a confliggere con il principio di sperimentazione che risulta improponibile rispetto alla filosofia perenne della verità.
Ora, di fronte a questa coerenza intellettuale del mondo cattolico, vi è una parte del mondo sedicente laico – ad esempio l’ex presidente della Corte Costituzionale Zagrebelsky, professore della sinistra con venature liberali – sostiene la necessità di elaborare un’etica laica dei diritti, affermando “Se le nostre società laicizzate fossero portatrici delle risorse morali sufficienti per fondare un’unità durevole non subirebbero il ricatto clericale”. Una simile impostazione, tipica dell’anticlericalismo, è opposta a quella della separazione Stato religione sostenuta dai liberali, i quali per coerenza non possono concepire un’etica qualsiasi ma un’etica ricondotta al suo significato stretto di morale dell’individuo. Vale a dire solo un’etica condivisa delle regole civili e quindi ad un’etica molto attenta a non proporsi obiettivi rigidi che fanno a pugni con diversità individuale e senso critico. Insomma l’etica del separatismo è un’etica strutturalmente provvisoria rispetto al mutare delle circostanze e al passar del tempo. Dunque è un’etica che non si prefigge (e si illude) di rovesciare l’etica religiosa. Per questo, chiunque si dica laico non può poi pensare, per puro conformismo, di “ripartire da un patto serio, leale e corresponsabile come il Concordato”, come ha detto Zagrebelsky. La logica del Concordato – al di là della sua storia – è infatti l’esatto opposto della logica della separazione.
E infatti si oppongono al solo parlare di separazione quelli che nel mio Lo Sguardo Lungo chiamo i cattolici chiusi, che vivono sul e per il Concordato e ne difendono accanitamente la logica. Assai di più di quanto faccia la stessa Chiesa, la quale ha mutato posizione, ha abbandonato la teoria del temporalismo, ha fatto uscire lo strumento concordatario da quelli considerati a presidio della pratica religiosa negli Stati democratici e si è affidata alla sua missione religiosa nel sociale. Al contrario, i clericali CHIUSI, in buona parte esterni alla gerarchia, continuano imperterriti a sostenere il sistema concordatario ed i suoi inevitabili privilegi. In fondo, vogliono salvaguardare più che la Chiesa, la loro funzione di intermediari – ed i connessi privilegi – nelle trattative concordatarie tra Stato e Chiesa.
Attribuiscono di fatto al Vaticano la doppia funzione di Stato estero territoriale e di organizzazione religiosa in Italia. Il che rende ineludibile la doppia sovranità. Sia per gli appartenenti alla gerarchia, che per i comuni cittadini di fede cattolica compenetrati nella
3
logica concordataria, oltre che nella fede (i più recenti episodi di zelo dei cattolici chiusi, sono quello del direttore del carcere di Genova che a fine d’anno ha auspicato che la Chiesa sia una guida politica per il governo Monti e quello che non i partiti dell’attuale schieramento maggioritario bensì il segretario della CEI abbia dovuto ricordare che la questione delle esenzioni IMU anche agli immobili della Chiesa non esclusivamente commerciali fosse competenza esclusiva della legge italiana e non riguardasse né Concordato né Intesa). Solo quando si applica il principio di separazione Stato religioni, non si pone più la questione della rivalità nello stabilire le regole di convivenza. Alla religione (tutte) è garantita una condizione di piena libertà per esercitarla in privato e in pubblico, ma non viene riconosciuto alcun privilegio temporale. Nei rapporti di convivenza la tradizione religiosa non può eludere l’impianto della Costituzione. Nessuna doppia sovranità. La libertà di religione non ha nulla a che vedere con i privilegi alla religione.
Un altro esempio di antiseparatismo è la ritrosia, mascherata con la precauzione, ad effettuare la ricerca. Lo spirito liberale è inseparabile da quello della ricerca. Lo liberale ha come principale caratteristica il non essere uno spirito teorico ma operativo di ciascuno. Quindi non può limitarsi, nello sforzo di capire, ad osservare il mondo vagheggiandone modelli che facciano smettere di osservare. E neppure può rinunciare ad imperniarsi sull’esaminare i fatti alla luce della miriade di punti di vista di individui diversi, seguendo invece un’autorità per fede. Se lo facesse contraddirebbe i suoi stessi principi. Il liberale ha capito che nessun libro è scritto una volta per tutte e che perciò è impossibile trovare la strada della conoscenza nel solo studio di un testo. Perciò la ricerca con metodo scientifico è l’essenza dello spirito liberale. Una continua applicazione della ragione critica sui fatti, consapevole di essere lo strumento insuperato per conoscere di più appunto perché non pretende di conoscere definitivamente tutto.
Tutte queste differenze tra le caratteristiche del separatismo e quelle dell’antiseparatismo non solo non possono passare inosservate, ma trovano un banco di prova ineludibile nei fatti della vita. Proprio per questo l’intero mondo cattolico sta seriamente riflettendo sul significato di convivere nella società italiana attuale, multietnica e multireligiosa. Non va scordato che per riflettere la CEI ha tenuto cinque mesi fa il Convegno di Todi tra tutte le organizzazioni cattoliche che non stanno nel clero e sono nel sociale. Ed in quel Convegno, quasi a riprova della tesi del mio libro a proposito di separazione e dei cattolici chiusi, sono emersi due atteggiamenti nettamente distinti.
Il primo atteggiamento è quello della CEI, individuare una nuova classe dirigente e nuovi leader in grado di realizzare un soggetto culturale e sociale capace di interloquire con la politica. Un obiettivo nel solco della linea Vaticana, che punta ormai alla presenza nel sociale. Ed è stato confermato dal cardinale Bagnasco, che ha detto: “Il principio di laicità inteso come autonomia della sfera civile e politica da quella religiosa ed
4
ecclesiastica – ma non da quella morale – è un valore acquisito e riconosciuto dalla Chiesa e appartiene al patrimonio di civiltà”. Queste parole esprimono il legittimo magistero religioso cattolico. Per cui niente da dire per credenti e non credenti che non si identificano con la cultura prevalente nelle organizzazioni cattoliche. Pur se non li deve lasciare indifferenti. Perché? Finché le riflessioni attengono agli aspetti religiosi e al coniugare lʼetica sociale con lʼetica della vita, esse riguardano solo chi ne condivide le conclusioni. Quando poi le riflessioni aspirano a fare proseliti e, con la scusa della socialità, qualcuno pensa di imporre agli altri cittadini le conclusioni del proprio credo, allora si profila il pericolo di debordare dal campo religioso e di toccare aspetti dell’organizzazione civile.
Qui sta la vera questione della convivenza tra diversi. Non sulla religione, che è un diritto di ciascuno. Perché la religione corrisponde ad una propensione innata dell’animo umano, come sostiene negli scritti di una vita il neo cardinale belga Ries nominato ultra novantenne dal Papa appunto per sottolineare questo aspetto. Una propensione che ciascuno ha il diritto di avere. Solo che la vera questione della convivenza tra diversi sta altrove, sul come si vogliono costruire le istituzioni civili. Se si vogliono sempre adeguate al convivere tra diversi cittadini od invece se si vogliono finalizzate ad imporre il conformismo comunitario di cittadini identici per religione. Già da questa considerazione deriva che Todi conferma di per sé la necessità che i fautori del principio di separazione Stato religioni si mobilitino per introdurlo nell’architettura istituzionale. Per evitare che prendano piede le tesi religiose civilmente pericolose, come quella, ribadita in questi giorni, secondo cui “l’Italia ha un vitale bisogno di una cultura del bene comune e della responsabilità sociale condivisa”, concetto che non casualmente esclude ogni idea di sovranità del cittadino individuo e ripercorre la strada fallimentare della socialità comunitaria. Per evitare questo e non dover aspettare comportamenti saggi della Chiesa, come la rinuncia al grande Ospedale San Raffaele di Milano, caratterizzato da elevate professionalità però contrastanti con una ricerca secondo la dottrina cattolica. Non a caso su quel tema dell’Ospedale, il mondo delle professioni laiche si è mosso.
Ma è il secondo atteggiamento emerso a Todi a fornire una prova pressante dell’urgenza di sostenere il separatismo. Dopo che il documento conclusivo aveva ripreso la linea del cardinale Bagnasco, una parte consistente delle associazioni ha voluto chiarire con una conferenza stampa presieduta dal Segretario CISL, quale è la loro idea dell’interloquire con la politica: approfittare di Todi, non per parlare della sfera morale, bensì per lanciare una richiesta che è squisitamente politica di partito. Si è chiesto in nome dei cattolici un governo più forte, per evitare le elezioni anticipate e per una riforma elettorale proporzionale con le preferenze. Cose che, comunque la si pensi, attengono alle valutazioni politiche di ciascun cittadino, non alla sua religione. L’accostare la Chiesa e la CEI alle formule della battaglia politica quotidiana, sfruttando il megafono dei mass media scodinzolanti alla parola cattolico, è l’ennesima clamorosa dimostrazione che le
5
spinte a proseguire nel temporalismo vengono da parte di coloro che utilizzano le problematiche religiose per coltivare i propri privilegi terreni. Quelli che ho chiamato i cattolici chiusi. Vogliono imporre a tutti il proprio credo facendone una spinta per i loro interessi terreni e, se riescono, una fonte legislativa.
Di fronte a questa realtà materiale, credenti e non credenti, non devono limitarsi ad essere convinti del separatismo individualmente. Devono reagire all’atteggiamento dei cattolici chiusi. La convivenza liberal democratica è fondata sul conflitto secondo le regole tra tutte le opinioni e giudizi. Dunque è fondamentale una parità nel conoscere le diverse posizioni per evitare che, mancando la consapevolezza, si finisca per decidere regole disequilibrate e per truccare il conflitto democratico con i privilegi. La libertà di ciascuno cittadino è più protetta dalle regole istituzionali neutrali che evitino privilegi religiosi per qualcuno.
Stabilire tale parità rispetto ai cattolici chiusi, significa contrastare in nome della libertà la loro pretesa di avere privilegi. Di conseguenza il mondo dei sostenitori del principio di separazione Stato religioni, deve darsi una mossa. Deve agire nella carne delle relazioni civili, per irrobustire il clima politico culturale a favore della separazione Stato religioni, superando l’anomalia italiana al riguardo. Sulla ricerca, sulla procreazione medicalmente assistita, sulle indicazioni anticipate di fine vita, su tanti grandi e piccoli privilegi e su una serie di mentalità collaterali. Sono tutte tematiche indispensabili per attuare davvero la sovranità del cittadino e come è ovvio sono legate strettamente al principio di separazione Stato religioni. Da qui deve sorgere l’impegno della cultura laica a prendere l’iniziativa sul piano civile per evitare che la fede divenga la fonte legislativa.
Tanto più che è la stessa quotidianità a spingerci verso questo atteggiamento. Perché il governo Monti, nato dalla crisi internazionale e dalle dimissioni di Berlusconi, ha tirato fuori il paese dal precipizio incombente e sta perseguendo l’obiettivo di salvare il nostro paese delle gravi carenze interne in materia di debito accumulato e di strutture obsolete su sviluppo e tassazione. E per poter avviare il risanamento ha cambiato innanzitutto il clima politico e il tono del dibattito. Questo secondo obiettivo non può ridursi al tratto personale più sobrio e raziocinante di chi è abituato alle aule universitarie e alle sale dei vertici rarefatti economico finanziari. Perché la sostanza delle contrapposizioni politiche, sono i problemi reali dei cittadini. E il tema della separazione è uno di questi, tra i più importanti. Sul punto sono venuti segnali variegati dal governo in questi due mesi, anche se va detto che la rotta appare interessante, seppur in qualche modo necessitata.
Intanto, la crisi ha sospinto nelle retrovie la normativa sul testamento biologico che era già in dirittura di arrivo per la definitiva approvazione al Senato in una versione letteralmente contraria a passi della Costituzione, che vorrebbe risolvere in modo impositivo tipiche scelte individuali. E finora non se ne è più parlato, meno male. A fine
6
novembre, il Ministro Ornaghi fece un ragionamento ambiguo sulla presenza della Chiesa e il fondamento della democrazia. Specificando che dall’Ottocento in poi il progresso e lo sviluppo economico hanno portato la contrazione e la perdita di valore del «sacro», disse che davanti la fine delle ideologie novecentesche la “rivincita di Dio è la visione del futuro”. Solo che in Italia non occorre un’ispirazione religiosa per costruire istituzioni sulla sovranità del cittadino in una società multietnica. Circa due settimane dopo, un altro Ministro, Riccardi anche lui relatore a Todi, sul problema dell’ICI ha invece rimbeccato vari deputati dell’UDC, del PD e del PDL che ritenevano giusto esentare la Chiesa dal pagare l’lCI.
A gennaio nell’incontro con il Papa, Monti, impeccabilmente, non ha baciato l’anello, lo hanno fatto tre suoi ministri, e non erano quelli di Todi. Poco dopo al Senato, lo stesso Monti ha detto che quanto al riconoscere le radici giudaico-cristiane “ciascuno di noi, me compreso, può avere una preferenza affinché vi sia, ma è importante vedere che la Ue incarna valori etici che molto più spesso sono stati assenti nelle politiche degli Stati, anche nel nostro Paese, come giustizia distributiva ed equità intergenerazionale”. E in questa logica, del non rinnegare il suo personale cattolicesimo, Monti ha imposto l’emendamento sull’IMU per rendere le esenzioni IMU accettabili in Europa: l’esenzione riguarda le modalità non commerciali, sennò l’immobile paga l’IMU chiunque ne sia il proprietario. Ha cioè operato come Capo di Governo all’europea che non si inchina ad esigenze in contrasto con la laicità istituzionale. La laicità istituzionale è affidarsi alla diversità del cittadino in tutte le diverse espressioni. Non rispettarla non è equo. Il primo passo è impedire che le esenzioni IMU siano utilizzate per distorcere la concorrenza. E, attenzione, questo non riguarda solo la Chiesa ma tutto il mondo assistenziale che finora ha utilizzato le esenzioni.
Eppure, chi vorrebbe finanziare con soldi pubblici i propri principi, è immediatamente saltato su chiedendo di interpretare la nuova regola nel senso che le scuole parificate dovrebbero essere esentate dall’IMU al pari di quelle pubbliche. La semplice coerenza con il principio base dell’emendamento dovrebbe impedire distorsioni della concorrenza (perché violano i trattati europei). Infatti, le scuole parificate rientrano nella libertà costituzionale di impresa nel settore educativo ma non in una libertà di insegnamento privato a carico dello Stato, che non c’è e non ci deve essere. La libertà di insegnamento privato è possibilità di insegnare cosa si vuole, non di essere finanziati per farlo. Sostenere il contrario – e cioè che solo con il finanziamento pubblico si potrebbero insegnare alcune importanti culture – significa non riconoscere la funzione educativa pubblica come connettivo del convivere tra soggetti culturalmente diversi e dichiarare che per istruire secondo gli indirizzi della famiglia sarebbero leciti recinti protetti decisi solo dalla famiglia a spese delle istituzioni. Il percorso educativo privato è ammesso ma non con il contributo spese di tutti gli altri. Altrimenti la convivenza salterebbe subito e si avrebbe l’integralismo multiculturale tra ghetti invece del pluralismo liberale. Di fatti
7
una scuola è parificata quando la sua gestione privata segue programmi e regole dello Stato. Quindi, se non è un raggiro, una scuola parificata non esprime la privata libertà di insegnamento, bensì una scelta di impresa nel settore educativo. I cattolici chiusi (dominatori della grande stampa) dicono che allevierebbe i compiti dello Stato. Ammesso sia vero, dirlo non significa che lo Stato articoli i propri compiti dando privilegi fiscali e soprattutto non elimina l’interesse imprenditoriale d’origine (genera introiti, se fosse gratis avrebbe già l’esenzione IMU per gli usi culturali). E dunque la concorrenza d’impresa non va violata.
Pertanto, con il criterio della sovranità di cittadini diversi, l’esenzione IMU non si applica alle parificate. Così come ad ogni attività, anche gestita dal volontariato, che abbia caratteri economici (tipo strutture commerciali no profit). La finalità del proprietario non deve indurre esenzioni IMU. Il proprietario, quanto guadagna con l’attività commerciale, al netto delle imposte, può utilizzarlo come vuole. Ma aumentare il guadagno, o solo pareggiare i costi, diminuendo le imposte in base ai fini della proprietà, avvantaggia un potere di fatto. Le istituzioni, specie oggi, non devono finanziare le scelte dei convincimenti privati. La crescita del sistema si fa con prodotti e servizi validi, non con la droga dei privilegi a qualcuno.
Insomma, la questione dei rapporti del governo Monti con i cattolici è ineludibile. Nei prossimi mesi, i ministri si dimostreranno ministri normali di personale religione cattolica oppure vorranno essere cattolici chiusi divenuti ministri? L’importante non è rispondere a questo interrogativo essenziale. Basta porselo, per tornare subito alla decisiva questione separatista. I laici, credenti e non credenti, debbono decidersi ad uscire dalle catacombe. Devono far pressioni da subito nel nome della politica laica di separazione. Che, come si è appena visto sul caso scuole, non concerne solo la materia dei rapporti Stato religioni, bensì un modo di essere civile che si applica in diversi settori. Principalmente, in quello di cambiare mentalità istituzionale.
Sul piano europeo, i fautori della separazione devono impegnarsi sulla nuova frontiera degli attacchi dei cattolici chiusi, non più sulla mancata inclusione delle radici giudaico cristiane (come ricorderete richiesta anche dai due rappresentanti dell’Italia, Frattini e Amato) – e che anzi, si cerca quasi di far dimenticare che la si voleva – ma utilizzando il Preambolo del Trattato che fa un riferimento ad una serie di radici, insistono sul dialogo Stato religione che il nuovo articolo 17 del Trattato imporrebbe. Si tratta di un tentato raggiro, testi alla mano del Trattato. Intanto l’art.10 cataloga la religione insieme alle convinzioni personali (così come la razza o l’origine etnica oppure età od orientamento sessuale). E ciò conferma che la religione non ha un ruolo particolare, separato e distinto rispetto alle convinzioni personali. Tesi che è un cardine delle concezioni separatiste, non per caso nel mirino dei cattolici chiusi, i quali preferiscono parlare di libertà della religione piuttosto che di libertà di religione, cioè spostare l’accento dal cittadino alla
8
collettività religiosa.
Quanto all’art.17 non impone nessun particolare dialogo Stato religioni. Definisce un quadro generale di criteri nei rapporti confessionali e non confessionali. Al comma 1, stabilisce che per le Chiese restano impregiudicate le regole di convivenza vigenti in ciascun stato membro, nel rispetto dell’attaccamento europeo a libertà e diritti dell’uomo sancito dal preambolo. Al comma 2, si estende il comma 1 alle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Questo equivale a non riconoscere uno status particolare alle Chiese e all’associazionismo religioso. Lo stesso concetto viene ribadito dal comma 3. Infatti l’Europa assume l’impegno di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e organizzazioni dei commi precedenti, riconoscendone l’identità e il contributo specifico. Il che è una chiara dichiarazione di separatismo, dato che l’istituzione pubblica riconosce l’identità e il contributo alla convivenza dato da ogni corpo individuale e sociale, senza privilegiare e preferire nessuno.
Queste sono le considerazioni che i laici devono opporre apertamente e con decisione, quando i cattolici chiusi tentano i loro raggiri. Fa quasi sorridere che essi magnifichino i concetti di libertà di pensiero, di coscienza e di religione che costituiscono l’anima del laicismo e che non sono sempre sono stati rispettati da organizzazioni religiose (ad esempio la libertà di cambiare religione). Oppure quando si sostiene che il secondo comma dell’art.17 del Trattato garantisce l’art.7 della Costituzione italiana, mentre basta leggerlo, l’art.17, per vedere che la norma sul Concordato è legata solo alla volontà degli italiani, non quella degli europei. Oppure quando si sostiene che il terzo comma di questo stesso articolo stabilisce un percorso da parte delle istituzioni europee che esse non stanno facendo. Ed anzi si auspica la formazione di un comitato interno alla Commissione per dare spazio alle Chiese. Quasi che il dialogo con le religioni e le organizzazioni filosofiche fosse previsto come un monopolio dalle religioni riconosciute quale controparte in trattative di potere e sindacali con il governo della UE.
E quanto all’Italia, oltre le tradizionali importanti tematiche di tipo costituzionale, dal punto di vista della logica separatista c’è da affrontare il problema del clima istituzionale diffuso. Ci si ispira troppo alle reti di amicizie disinvolte per ottenere gli agganci conformistici al potere imperante, agganci mediante reti che sono espressione del modello istituzionale basato sulla logica dei privilegi strutturali dati a qualcuno. Come ha scritto sul Corriere il sociologo De Rita, la cultura cattolica ha avuto una storica indulgenza per l’egoismo individuale, il familismo amorale e il particolarismo categoriale. Ed è quasi logico dato che con queste cose si minano senso critico e responsabilità del cittadino. Inoltre, nel medesimo quadro, si dimentica troppo che il rispetto delle leggi non è un’imposizione etica ai cittadini ma prima di tutto deve essere esercizio della funzione pubblica di controllo ordinario con il fine che le leggi siano applicabili e vengano applicate. Soprattutto occorre dismettere ogni logica economica
9
pauperistica, che non è meno pericolosa e sterile di quella classista (tant’è che Cavour abolì gli enti mendicanti per indirizzare sul lavoro) e ispirarsi al confronto delle competenze e dei meriti che porta allo sviluppo.
Le omissioni in tema separatista da parte laica, favoriscono l’ipoteca dei cattolici chiusi sul clima politico. La prima è cedere alla tentazione di replicare a simili impostazioni sul piano religioso, cosa che è una contraddizione con la laicità liberale. Discutere sulla religione e con la religione era storicamente comprensibile secoli fa, quando ancora il potere religioso avvolgeva la convivenza pubblica in tutti i suoi aspetti. Oggi che la necessità di non sovrapporre Stato e religioni è divenuta una consapevolezza largamente acquisita (anche se purtroppo scarsamente praticata in Italia), il laico deve garantire la libertà di religione ma sul piano civile non deve discutere d’altro in materia di religione. Non negare mai i fatti e confrontarsi sempre con il loro manifestarsi – che è il marchio distintivo della laicità – non è per nulla traducibile nell’accettare una presunta legge naturale che ci sovrasta. Al contrario. Rende centrale la sperimentazione e il concepire le regole come necessità per adeguare la convivenza ai tempi. E dunque, per forza di cose, adotta regole quali forme convenzionali e mutevoli con i luoghi e i tempi.
Sul punto i laici non devono essere rinunciatari e devono mantenere sempre viva la polemica contro i cattolici chiusi. I quali operano sul piano civile e su questo piano propalano la falsa accusa della laicità che distrugge qualunque norma etica nel mondo. Non è che le regole laiche, siccome convenzionali e non rigide, non abbiano una loro valenza e non diano una sorta di indicazione morale per i comportamenti di ciascuno. Il contenuto lo hanno, ma d’altro genere, coerente con la laicità. La loro è, come detto prima, un’etica strutturalmente provvisoria rispetto al mutare delle circostanze e al passar del tempo (per i laici l’importante non è dichiarare certi valori indiscutibili, è sapere, in base a radicatissime esperienze di fatto, che, pur essendo tutto discutibile quanto a metodo, alcuni valori sono irrinnunciabili in pratica per sviluppare la libera convivenza tra individui diversi). Su queste dispute concettuali occorre che il mondo laico sia molto più determinato di quanto finora non sia stato. Non cedendo a suggestioni imitative verso l’etica cattolica e non cercando altre etiche rigide, quasi quella laica fosse un’altra chiesa.
Anzi, proprio questa considerazione induce a sottolineare che dal singolare dell’epoca di Cavour – Libera Chiesa in Libero Stato – oggi si deve logicamente passare al plurale della separazione Stato religioni. Libertà di religione e neutralità come principio valgono nei confronti di ogni credo. Qui ho parlato di più del credo cattolico perché questa è la realtà predominante nel nostro paese. Ma ormai, oltre le tradizionali realtà dell’israelismo, dei valdesi, delle svariate forme protestanti, del buddismo, quantitativamente più piccole, occorre tener conto della realtà islamica che in Italia veleggia verso i due milioni di persone, e tutti pesano nella convivenza anche se non hanno la forma organizzativa della
10
Chiesa cattolica. E verso di loro si richiede la laicità istituzionale che solo la separazione Stato religioni rende possibile.
Allora, comportarsi in coerenza con i propri principi, per i laici ha l’importante obiettivo di equilibrare la pressione dei cattolici chiusi nella convivenza democratica e nell’azione legislativa. Come si è visto i cattolici chiusi si arrovellano per contribuire a diffondere il principio della legge di natura all’insegna della filosofia perenne. I laici sono invece impegnati a sostenere il primato della sovranità del cittadino nel quadro di un mondo che cambia e di una convivenza secondo le regole scelte. I cattolici chiusi propugnano quale criterio civile la dottrina sociale della Chiesa in cui si incarna la fede nella divinità, i laici sostengono la logica della separazione Stato religione che si affida alla diversità delle intenzioni, al cambiamento nel tempo e alle variabili scelte negli ambiti di convivenza secondo regole che rendano possibile il massimizzare i diritti di ogni individuo. Lo scegliere periodicamente e affidare le scelte alle decisioni dei singoli cittadini è la direttrice essenziale del modo di essere laico. Nessuna ricerca di beni comuni e di interessi generali, che non rientrano nella logica della scelta. Esprimono piuttosto l’ossessione di corrispondere ad una autorità superiore oppure ad un ampio conformismo maggioritario insofferente per le valutazioni critiche e che emargina le minoranze di altri cittadini.
Ecco perché la partecipazione civile è intesa dai religiosi in altro modo che dai laici. Per i religiosi la partecipazione civile dovrebbe essere analoga a quella praticata nella Chiesa, e allora la partecipazione non implica decidere, dato che il Popolo di Dio non è un popolo che decide, a decidere pensa la gerarchia piramidale di chi ha preso i voti della fede. Per i laici coerenti, partecipare, se non vuole essere pura cortesia rituale priva di incisività, è concepito per giungere ad una scelta tra le indicazioni di ciascuno. Di conseguenza per i laici il consenso non può mai essere per la persona in sé ma per le idee e il progetto di cui il cittadino è portatore. Questo ricercare il consenso soprattutto per le idee e il progetto, è in Italia indispensabile se si vogliono svecchiare strutture la cui fatiscenza non è ormai più nascondibile. Troppi paiono non essersi accorti che da almeno un decennio esiste nel mondo la globalizzazione, che non consente il provincialismo protezionista delle intese ammirabili separate dal come funzione il sistema paese complessivo.
Fino all’avvento dei tecnici, molti, ignorando tutto ciò, stavano lavorando all’unire l’area cattolica su valori di tipo religioso. Ho detto della divaricazione emersa a Todi tra il Convegno e la conferenza stampa post Convegno dell’associazionismo improntato ai cattolici chiusi. La divaricazione non è piaciuta alla gerarchia, che ha felpatamente preso le distanze e nei giorni scorsi, in un altro Convegno sulla formazione sociopolitica, ha di fatto escluso che la crescita di una nuova generazione di cristiani impegnati possa ridursi ad esperimenti neocentristi. Perché i cattolici sarebbero una corrente e non un popolo unito mentre l’associazionismo cattolico deve imperniarsi sui valori non negoziabili
11
dell’antropologia religiosa. Proprio la questione antropologica è una posizione insistita del Vaticano e della CEI che trova ascolto anche in significativi settori postmarxisti preoccupati che i processi di globalizzazione, in mancanza di un nuovo ordinamento internazionale, pongano in crisi il meccanismo democratico. Appunto perché solo l’ordine internazionale potrebbe mettere la camicia di forza all’individualismo metodologico.
Questi atteggiamenti sono fisiologici su piano della fede religiosa, che si sforza costantemente di sterilizzare il passare del tempo e la variabilità. Ma tradotti sul piano civile divengono la radice del cattolicesimo chiuso. I valori religiosi non possono fondare un partito. Il solo modo di garantire la libertà religiosa di ciascuno, è battersi per istituzioni neutrali. Poi ogni cittadino sosterrà quel che crede e si comporterà come crede in un ambito legale. Questo cominciano a sostenerlo anche esponenti del clero. Non fare niente pur professando il separatismo individualmente, equivale a non praticare il separatismo. Poiché il separatismo vuol ribaltare la concezione del proselitismo propalata storicamente dai partiti ideologici. La propaganda non è per intrupparsi. E’ per consentire a ciascuno di conoscere, di ragionare e di essere libero a suo piacimento. Senza che la legge imponga un credo religioso, oppure una morale pubblica, oppure inneggi al tassare e trovi sempre il modo di rinviare il taglio di quelle spese pubbliche, che, snaturando la loro funzione di riequilibrio nella convivenza civile, sono divenute la ragione di vita per burocrazie autoreferenziali. Le istituzioni devono essere il sostegno aperto alla convivenza tra cittadini diversi. Una convivenza tra diversi che ha necessità, per non essere frammentata e per guardare al domani, di restituire centralità alla politica vera delle idee e dei progetti.
12