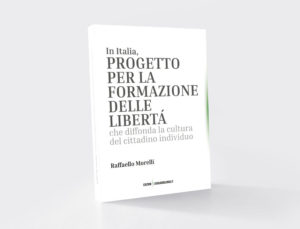Scritto per LIBERALI OGGI, numero unico su Il Contributo dei Liberali per l’Unità d’Italia, la democrazia, il progresso
Da tempo gli storici annoverano Cavour (Torino 1810-1861) tra i massimi statisti italiani. Eppure, da molti decenni, Cavour è visto con fastidio da buona parte delle classi dirigenti, dai clericali di sinistra e di destra, dalle burocrazie e, più di recente, da ampie fasce del mondo giornalistico. Lo hanno confermato le celebrazioni del 150° dell’Unità. C’è stato il chiaro tentativo di intestare l’Unità solo a due tra i suoi fautori di allora (Garibaldi e Mazzini), escludendo innanzitutto Cavour che ne individuò ed attuò la linea politica. Tanto che c’è voluto l’intervento del Presidente Napolitano nel discorso ufficiale sui 150 anni. Tratteggiate le precedenti analisi mazziniane, ha detto “l’Unità non poté compiersi che sotto l’egida dello Stato più avanzato… sotto l’egida della dinastia sabauda e della classe politica moderata del Piemonte, impersonata da Cavour. Fu quella la condizione obiettiva riconosciuta con generoso realismo da Garibaldi, pur democratico e repubblicano..”.
Non basta. Se dell’Unità d’Italia è stato celebrato il 150° anniversario, non così per l’altro 150° anniversario, quello del principio di separazione Stato religioni. Che pure è coevo, dato che Cavour pronunciò il Libera Chiesa in Libero Stato durante il dibattito su Roma Capitale svoltosi insieme al passaggio da Regno di Sardegna a Regno d’Italia (marzo 1861).
La riluttanza verso l’opera di Cavour sta nel dover ammettere che le sue scelte e azioni politiche – liberali – funzionarono allora e sono all’origine di prospettive tuttora feconde. Il che turba la cultura avvinghiata al conformismo di potere e avversa alla convivenza come diversità, che vuol rimuovere proprio la cultura della diversità (nonostante che temi essenziali della vita quotidiana esigano, per essere affrontati, di adottare tale cultura).
La colpa di Cavour era parlare di riforme per attuarle. Non ancora Presidente del Consiglio, disse in Parlamento che “le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l’autorità, la rafforzano”. Per Cavour – lo mostrò in diversi campi – le riforme si fondano su una diade, attenzione ai fatti reali e spazio alle iniziative del cittadino. Da qui la drastica lotta al potere temporale della Chiesa e ai suoi privilegi, allora un problema concretissimo. E poi l’Unità d’Italia non appena ne vide la possibilità reale, in base ai fatti che erano le opportunità diplomatiche europee e la collaborazione con chi fosse disponibile. Di pari passo, prese corpo l’idea innovativa dei rapporti tra Stato e Chiesa in chiave di separazione.
E’ la diade politica la causa del fastidio verso Cavour. Attenzione ai fatti (il realismo di cui ha tenuto conto Napolitano) e sovranità del cittadino vengono percepiti ancor oggi come un attentato (da evitare) agli equilibri di potere consolidati, ideologico economici. Da un lato mettendo in discussione il modo di decidere tra i singoli cittadini (cioè il parlamentarismo di cui Cavour fu iniziatore e che si vorrebbe sostituire sperando nella democrazia diretta). Dall’altro, in materia di convivenza tra vita terrena e vita spirituale, nascondendo la spinosa questione dei rapporti tra Stato e Chiesa che Cavour aveva con lucidità chiamato per cosa è: espressione della battaglia tra libertà del cittadino ed autorità sul cittadino.
In Italia si convive mischiando l’utopia a modelli statici e fuori del tempo. Sia da parte del mondo religioso istituzionale che da quello marxista. L’accusa agli indirizzi cavouriani è di non puntare sulla convivenza popolare delle masse, bensì sulla sovranità del cittadino individuo. Secondo loro, sarebbe impossibile pensare al futuro senza avere prima un obiettivo bandiera cui tendere (per dar certezza dicono) che loro, le élites religiose e rivoluzionarie professionali, avrebbero il privilegio esclusivo di poter indicare. Ed oggi sta aggiungendosi una nuova pratica utopica, che dissolve la progettualità del cittadino bloccandolo nell’attimo. Invece di porsi quale è – come protesi che potenzia le capacità relazionali conoscitive di ogni singolo – tale nuova rete interconnessa si presenta come una realtà virtuale che supera quella dei fatti. E che illude chi la usa acriticamente, di essere partecipe e protagonista nel decidere, mentre lo ingloba in demagogiche credenze teoriche con la pretesa di rappresentare la comunità degli utenti. Viceversa, i due punti di Cavour, il parlamentarismo e il principio di separazione, hanno sempre puntato sul cittadino nella sua concreta irripetibilità individuale, sulla sua consapevole diversità e sul suo senso critico, per convivere e per conoscere in relazione ai fatti. L’esperienza storica ha mostrato che il separatismo, cogliendo la diversità nella convivenza, produce più libertà e più benessere materiale. Chiudersi nei rapporti virtuali equivale al rifiuto della realtà sperimentale.
Distinguendosi dai modelli statici, dalle prospettive utopiche e dai mondi virtuali, Cavour non proponeva una identità unica né faceva prevalere una convinzione specifica. Fondava la convivenza civile sulla sovranità dei diversi cittadini invece che sull’autorità di un potere. Così usufruendo dello spirito critico di ognuno, delle sue iniziative, delle sue relazioni innovative e, cosa decisiva, consentendo l’evolvere nel tempo della vita.
La strategia cavouriana porta alla laicità delle istituzioni, che si caratterizza per due capisaldi. Il primo, è la piena libertà di religione del cittadino, che applica la congenita tolleranza della laicità e della convivenza tra diversi individui. Stare insieme non obbliga ad appartenere alla medesima comunità o ad avere le stesse convinzioni religiose. Stare insieme tra diversi significa accettare la comune prova dei fatti e tessere le rispettive relazioni condividendo le regole pubbliche.
Il secondo caposaldo della laicità è la neutralità istituzionale in materia religiosa. Amalgama da un lato la laicità del sistema quale presidio della libertà di religione e dall’altro le differenti convinzioni religiose, personali e manifestate in pubblico, uguali per dignità e diritti. Sul punto, i conservatori cattolici parlano di provvedimenti di Cavour e dei liberali persecutori della Chiesa, scordando che all’epoca il potere temporale della Chiesa era pervasivo e che quei provvedimenti avevano lo scopo di sradicarlo. Tanto che il principio di separazione fu lanciato solo quando, superato il temporalismo, si trattò di far maturare il libero rapporto tra Stato e struttura religiosa. Perché la laicità istituzionale non esclude i non laici.
Cavour è ricordato con fastidio perché la diade politica guida del suo agire si è dimostrata efficace e lungimirante. Contrasta con la tendenza della nostra società ad identificarsi nel conformismo del potere immediato e dei rapporti amicali. Tendenza che contrappone alla attenzione ai fatti il rispetto delle convenienze di gruppo prescindendo dai risultati, e che contrappone alla sovranità del cittadino l’autorità sul cittadino da parte di qualcosa o di qualcuno. Vale a dire nella nostra società troppi accettano una struttura di privilegi (il sistema Concordatario è uno dei maggiori) lieti di utilizzarli a proprio vantaggio, anche se soffocano la convivenza.
In questo essa è più arretrata delle alte gerarchie vaticane. Che sono passate dalla ruvida difesa del potere temporale, al teorico abbandono del sistema Concordatario quale strumento della Chiesa nelle democrazie(Concilio Vaticano II), fino all’accettare che la politica è rappresentanza e la religione è testimonianza (il Segretario di Stato Bertone). Quindi, oggi per la Chiesa la religione non può confondersi con gli strumenti della democrazia con cui funziona la convivenza civile.
Nella nostra società tanti non vi arrivano ancora. Praticano il conformismo buonista, che salta il confronto tra diversi, e non la mentalità liberale che lo promuove. Cavour conosceva le difficoltà. Concludendo il dibattito disse: “Noi non possiamo immaginare uno stato di cose fondato sulla libertà ove non siano partiti e lotte. La pace completa, assoluta, non è compatibile colla libertà….. Ove questa conciliazione si compiesse, se la corte di Roma accetta le nostre proposte, se si riconcilia coll’Italia, se accoglie il sistema di libertà, fra pochi anni, nel paese legale i fautori della Chiesa, o meglio, quelli che chiamerò il partito cattolico, avranno il sopravvento; ed io mi rassegno fin d’ora a finire la mia carriera nei banchi dell’opposizione”.
Queste parole suscitarono ilarità prolungata. Ma avevano colto il punto. Oggi il temporalismo non c’è più ma c’è una conciliazione concordataria fisiologicamente fondata sull’autorità. La vogliono i cattolici chiusi, cioè quelli che per loro terrene convenienze intendono imporre a tutti il proprio credo e farne una fonte legislativa.
Sono le cose reali che portano i liberali a proseguire sui fatti la lotta civile tra il principio di libertà del cittadino e l’autorità sul cittadino. Il metodo di Cavour resta oggi attualissimo.