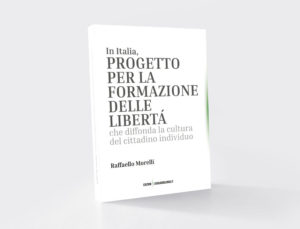Commento sul libro di Alessandro Bottoni sul tema DIRITTI DIGITALI
Cari amici,
dato che Bottoni ha cortesemente richiesto a tutti quelli della lista PP di leggere la prima bozza del suo libro e di dire cosa se ne pensa, mi sento in dovere di farlo.
Il libro è un pamphlet assai scorrevole che si legge bene senza alcuna pena letteraria e che mostra la lucidità professionale dell’autore, nelle questioni “tecniche” e nell’avvertire che le questioni “tecniche” hanno in realtà notevole influenza sulla convivenza civile. Per le questioni “tecniche” non mi pare esistano motivi di critica, anzi ve ne sono di forte apprezzamento. Per gli aspetti dell’influenza sulla società civile, invece, critiche ce ne sono e radicali. Si badi. Critiche non per l’invito conclusivo a favore di un uso responsabile della tecnologia digitale ( pag.36/37 ” il nostro peggiore nemico siamo noi che dovremmo conoscere la situazione prima di decidere ed invece non ci preoccupiamo di informarci; siamo noi che dovremmo agire con lungimiranza ed invece ci accontentiamo di pensare all’immediato…E’ tempo di reagire”) che condivido in pieno. Critiche per l’impostazione complessiva che non solo non è necessaria per inquadrare e sostenere le tesi “tecniche” e perfino contraddice la conclusione ma che in più diminuisce la credibilità del libro presso tutti coloro (che sono una quota molto ampia dei cittadini) che respingono per cultura l’approccio marxista. Con il risultato che, invece di essere un sostegno alla battaglia per la libertà di scambio sul web, il libro finisce per favorire i suoi avversari, i quali sognano appunto che il maggior numero di persone , rifiutando perché marxisti i ragionamenti a difesa della libertà sul web, lasci di fatto passare le pulsioni monopolistiche dei grandi fratelli commerciali e fondamentalisti.
Gli esempi di questa impostazione di tipo ideologico chiuso – oltretutto, insisto, superflua al fine della solidità della tesi “tecnica” e delle influenze sulla convivenza – sono diversi. Ad esempio, nelle pagine tra 13 e 19, si sostiene la necessità dell’anonimato come risorsa fondamentale di una informazione libera e di lotta politica. Ma questo è un riflesso di una concezione di lotta politica improntata al leninismo e non ha niente a che fare con la sacrosanta battaglia a favore della informazione libera e neppure con l’altrettanto sacrosanta difesa della privacy. Il privato attiene ad altro, come la razza, la religione, il sesso. Attiene anche alle idee politico culturali finché queste idee intendono confinarsi nelle libere convinzioni o nello studio. Ma quando intendono organizzarsi per un mutamento delle istituzioni in tempi più o meno brevi, allora esulano del tutto dal privato, poiché nelle democrazie libere la politica individuale si fa pubblicamente, non come associazioni segrete, che non a caso sono il sistema degli eversori di ogni colore e genere, terroristi inclusi. Ancora. Se si scrive che la comunicazione anonima tra persone è l’unico modo di mantenere in vita qualche forma di resistenza o addirittura di dissidenza, allora o è un modo soft per dire che occorre passare alla resistenza vera e propria armi in pugno oppure si dice una cosa che la grandissima maggioranza della gente non condivide e si incrina la credibilità del libro. Ancora. Perché mai i dipendenti Parmalat oppure gli iscritti ad un Partito che fossero a conoscenza di malefatte, non dovrebbero poterlo dire ai giornali ? Forse non potranno dirlo con accuse personalizzate se non hanno le prove, ma possono benissimo dirlo pubblicamente come critica al modo generale di funzionare della loro organizzazione. Addirittura mi permetto di ricordare che la libera democrazia è proprio questa trasparenza. Pensare di costruire una libera democrazia con l’anonimato è assurdo. Ancora. L’accostamento tra necessità di anonimato e tappare la bocca agli insider è fuori registro, dato che in economia gli insider sono quelli che usano le proprie informazioni ad esclusivo proprio vantaggio, non per informare i cittadini. Ancora, l’ossessione per l’anonimato si ritrova anche nella definizione e nelle asserite prerogative di un gruppo chiuso. Un gruppo legale non è chiuso perché l’identità dei soci è nota solo tra loro, registrata ma non diffusa . Un gruppo legale è chiuso a seconda della qualità e quantità dei contatti che esistono con le persone che non ne fanno parte. In nessun caso però il far parte di un gruppo chiuso dà il diritto “pubblico” di impedire che altri esterni al gruppo cerchino di conoscere per vie legali ciò che avviene all’interno. Perché le cose che avvengono potrebbero non riguardare il privato, ma , che so, lo studio di una rapina. E questo, quasi mai, si sa prima. Del resto la democrazia liberale è conflitto di interessi e intenti secondo le regole. Insomma, il tentativo di giustificare l’anonimato non regge, altrimenti si torna alle società medioevali. Tanto che a pagina 21 si sente il bisogno di ammettere che il firmare e dare la possibilità di farsi riconoscere è in fin dei conti una misura di civiltà.
Altri esempi dell’impostazione estranea alla logica delle questioni “tecniche” si ritrovano a pag. 22 e seguenti. Il primo è la forzata identificazione tra proprietà e controllo. Nel senso che possedere un oggetto non equivale affatto a poterlo utilizzare come vogliamo ; si può utilizzare solo nel limite di quello che l’oggetto può fare. Il fatto che oggi si tenda a limitare la duttilità degli oggetti digitali rispetto alle loro potenzialità, è (per noi ) un grave errore tecnico-concettuale da combattere in concreto con forza ma non tirando in ballo la scissione tra proprietà e controllo: non c’entra niente la scissione, poiché quello che compriamo non dà la proprietà di certi usi. Qui viene di nuovo fatta confusione concettuale sul come si sviluppa un sistema libero. Le soluzioni più giuste (più giuste nel senso di consentire ad ognuno di esprimersi come lui sceglie) non si ottengono stabilendo a tavolino e a priori quello che per tutti va bene e quando. Si ottengono facendo competere secondo regole concepite sulla base dell’esperienza e delle condizioni di fatto per raggiungere lo scopo dei cittadini liberi. Dunque occorre darsi da fare sul versante del competere e sul versante di ottenere regole adatte per consentirlo nel modo più aperto possibile. Senza questo laborioso impegno non si arriva alla libertà e la storia dimostra che rispetto ad esso non esistono scorciatoie. Se, come è scritto a pag. 25, non sarà possibile contare sull’aiuto dei legislatori ( che in fondo sono gli stessi cittadini) , chiedo su cosa si dovrebbe contare: sulla rivoluzione, sulle armi, su una palingenesi religiosa ? Ma via. Del resto, anche il mito degli industriali onnipotenti più volte evocato, è contraddetto, proprio nel settore informatico, dalll’esempio di Linux che prova tangibilmente come le singole gocce scavano anche la pietra.
Ulteriore esempio c’è a pag. 26 (“I nostri fornitori sono già diventati da tempo i nostri veri padroni”) ove riecheggiano toni da Capitale, forse per celebrare il 140° anniversario della sua uscita, nonostante che come è noto le sue previsioni non si siano realizzate. E poi a pag.28 dove ancora si evocano scenari apocalittici (“in futuro la situazione è destinata ad aggravarsi notevolmente”) e si tocca quello che forse è il punto centrale del sentire dell’autore in chiave ideologica: l’idea che il nostro destino sia se non nella proprietà dei mezzi di produzione, almeno in leggi che dettino i comportamenti produttivi chiave, quei 5 punti poi elencati a pagina 29. Di nuovo si badi bene. Almeno i punti 1, 2 e 3 sono auspicabili in sé e per sé ( a differenza del 4 e del 5 che sono dirigisti e basta ) ma è un grave errore volerli imporre alle aziende per legge. Si raggiungerebbe l’effetto contrario del dar più libertà agli utenti e ai cittadini (l’esperienza lo dimostra). Per essere liberi, le leggi devono essere costruite per mezzo del conflitto democratico e devono risultare operativamente coerenti alla libertà del cittadino. Dal libro sembra venire il rimpianto che non esista un qualcuno così saggio da poter decidere a tavolino le leggi giuste e poi così forte da imporle a tutti garantendo a tutti il conformismo di un certo modo d’essere. Ed invece io dico che meno male non esiste e non può esistere un qualcuno del genere. Ma comunque, per raggiungere gli indirizzi dei punti 1, 2 e 3 non è minimamente necessario ricorrere all’idea di imporli per legge. Possono essere ottenuti anche attraverso l’impegno dei cittadini attraverso l’uso del loro senso critico e la forza delle loro ragioni. Che è poi il sistema coerente con gli obiettivi da raggiungere.
Osservazione analoga può esser fatta a proposito dell’affermazione a pag.32 (” si deve sacrificare la sicurezza delle transazioni commerciali alla libertà di circolazione dell’informazione e della cultura”) . Il punto vero è che i sostenitori della libertà di circolazione facciano pressioni continue e forti per mantenere alta la consapevolezza di quanto sia importante questo aspetto. Il male è che i sistemi DRM possano prendere l’utente a tradimento, stendendo una rete di controlli all’insaputa di chi li adopera. E questo male non si aggira con un divieto legislativo che innesca un altro male, la produzione dirigista; si aggira potenziando il senso critico e la consapevole mobilitazione della gente, che sono la sola vera garanzia del mantenere la libertà di tutti. Prima ho richiamato l’esempio di Linux come fecondo modo operativo e ci torno ora per osservare ( a proposito della fine di pag. 34 ) che anche qui la contrapposizione reale non è tra commerciale e gratuito, nel senso che i programmatori di Linux non hanno raggiunto l’utopica società ove non esiste più il commercio siccome ognuno ha secondo i suoi bisogni. Hanno viceversa capito ( e messo in pratica ) che le loro capacità ed esperienza acquisite producendo i loro programmi liberi poteva essere retribuita in modi professionali diversi dalla retribuzione diretta di quei programmi. In sostanza, la retribuzione viene spalmata indirettamente su un numero di persone enormemente più grande e dunque si abbassa dal punto di vista dell’utenza singola , tanto che in alcuni settori può spuntare la gratuità. Niente nasce senza energia.
Per concludere. A mio parere occorre capire il vero intento di questo pamphlet. Se intende essere un saggio per interpretare le questioni “tecniche” dell’informatica e dei prodotti digitali alla luce dell’approccio marxista, non sono io titolato a poter dare pareri nel merito. Posso solo osservare che in questo caso il pamphlet si pone su un piano tutto diverso dalle finalità del PP e di certo non ne aiuta il perseguimento presso la massa dei cittadini. Se invece il pamphlet intende essere un saggio per sottolineare le connessioni tra le questioni “tecniche” dell’informatica e dei prodotti digitali con quelle della convivenza civile, allora collimerebbe con le finalità del PP ma in alcuni punti si imporrebbero ritocchi per eliminare la sovrastruttura ideologica, che, oltretuttto, mi appare francamente non necessaria e forzata. Appunto per questo parlo di ritocchi e non di stravolgimento del testo. E neppure ritocchi troppo complicati, dato che quasi sempre si tratta solo di togliere gli occhiali ideologici più o meno posticci e di inforcare quelli del senso critico propri delle stesse logiche operative profonde delle “tecniche” di cui si tratta. Si potrebbero fare esempi ma non credo che al momento sia il caso.