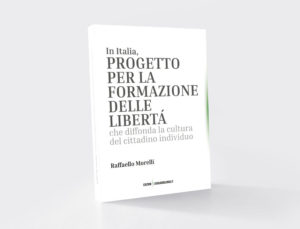Scritto per la rivista Libro Aperto
Lo snello libro di Tariq Ramadan “Islam e libertà” pubblicato da Giulio Einaudi è un saggio scritto su sollecitazione di un giornalista ( Andrea Romano, passato di recente da La Stampa al Riformista) al fine di illustrare in modo esplicito le tesi dell’autore sull’islamismo. Tariq Ramadam è un professore svizzero di famiglia egiziana, ora insegnante ad Oxford , musulmano riformista dichiarato ed impegnato a livello internazionale soprattutto in diverse attività sociali . Ramadan è una figura assai controversa , soprattutto perché molti – in Italia principalmente Magdi Cristiano Allam – lo accusano di tenere un “doppio linguaggio”, cioè di sostenere cose diverse a seconda della lingua utilizzata. Per un fine preciso, fare libera propaganda a favore delle organizzazioni musulmane a seconda del pubblico , al punto da conservare anche contatti con ambienti del terrorismo ( lui potenzialmente li avrebbe in quanto nipote del fondatore dei Fratelli Musulmani).
Qui non si intende mettere in questione la personalità di Tariq Ramadan ma le idee da lui descritte nel libro. Senza affrontare la possibile discrasia ( ammesso che le accuse fossero fondate) tra le sue idee e i suoi comportamenti, dal momento che Ramadan , non volendo essere una personalità liberale, di certo non vi è tenuto. Ora le idee di Ramadan che emergono dalla descrizione da lui stesso fattane nel libro , indicano una strada che può interessare il cittadino liberale italiano. Nel senso che un liberale ha specifico interesse che si estenda l’area della convivenza democratica quale è in concreto. In chiave liberale, il multiculturalismo e le sue conseguenze non sono affatto rifiutati in via pregiudiziale. Viene rifiutata l’idea di gestirli favorendone lo sviluppo per gruppi chiusi, che di per sé allontana l’attenzione dai singoli individui.
Sul punto, Ramadan scrive cose che appaiono utili ad una convivenza più aperta al riconoscimento dei valori occidentali da parte dei cittadini musulmani europei, se non ad una adesione. E questo anche se permanesse un filo di simulata ambiguità che , come è noto, è ammessa nel Corano. Per un liberale la questione vera sul libro è un’altra. Ramadan non scrive dal punto di vista del cittadino liberale bensì da quello del musulmano riformatore. E questo punto di vista, pervasivo , serve a sfornare molte interessanti osservazioni sui vari paesi europei ma di per sé conserva sulla convivenza un approccio di tipo religioso. Dunque, la lettura del libro è utile per capire le idee di un musulmano riformatore che non vuole considerare l’identità religiosa come preclusiva di altre identità a partire da quella civile. E questa idea è corretta dal punto di vista liberale. Invece, la lettura è di fatto superflua se, da liberali evoluti, si cercano innovative proposte operative oggi per modificare in senso migliorativo le regole della convivenza multireligiosa e multirazziale.
La cosa interessante in ottica liberale resta comunque che il libro di Ramadan non è fondamenalista. Il che non è poco in un’epoca in cui il fondamentalismo serpeggia in molte proposte, anche politiche. E di conseguenza, non essendo fondamentalista, il libro critica alcune usanze ( che peraltro Ramadan definisce più tradizionalii che coraniche) essenzialmente concernenti il terrorismo, le donne, l’indossare il velo islamico, le moschee, il preoccuparsi per l’antisemitismo Qui, l’importante non è che Ramadan abbia o no ragione dal punto di vista coranico; questa sarebbe una disputa da religiosi, del genere condotto da molti religiosi o non religiosi opportunisti. L’importante è che Ramadan faccia la critica , perché per farla adotta su queste materie la regola delle società liberali. La adotta nella sostanza senza ammetterlo in via formale, questo è vero. Tanto che scrive che occorre creare dei ponti di congiunzione tra ciò che è detto “civiltà” occidentale e ciò che è detto “civiltà” islamica, quasi non vi fosse stata prima una storia di rapporti civili differenti con esiti differenti. Tuttavia questo contestabile agire (quasi ripartendo da zero), non può far negare l’esattezza della necessità di costruire i ponti di congiunzione , lasciando da parte l’aspetto del perché prima non sia stato fatto. Quello che conta, è arrivare all’adozione dei criteri liberali di convivenza. Il merito e i tempi di come ci si arriva servono ad individuare il grado di liberalismo nell’arrivarci, ma, quando ci si arriva davvero, un liberale non lo rifiuta perché il percorso è stato contraddittorio, prolungato e quindi tardivo. Dice solo che permane la mentalità non liberale.
Il liberalismo attiene ai rapporti di convivenza. Gli specifici contenuti vengono coinvolti solo in quanto incidono su quei rapporti . Si possono condividere o meno i contenuti toccati da Ramadan, ma il significato di fondo delle idee di Ramadan è promuovere , anche se entro la cornice del religioso, il potenziamento espressivo del cittadini. II contenuto liberale può essere più o meno scarso, ma la cosa rilevante è se la linea normativa implicita sia al seguito della regola liberale. E’ quanto capita nel libro.
Personalmente, sugli specifici argomenti, ritengo che la linea comportamentale liberale dovrebbe essere differente. Ad esempio, non trovo giusto dare al terrorismo una motivazione sociale ( la povertà diffusa ovunque e in più la cattiva integrazione in occidente) quando il terrorismo per natura è invasato, totalitario, rifiuta il dialogo e le procedure; tuttavia trovo importante che il libro stigmatizzi gli attentati terroristici contro gli innocenti anche in nome della propria religione. Sulle donne, forse è un po’ facile distinguere tra religione musulmana e ancestrale pratica sociale di certe popolazioni musulmane, per poi scrivere che la mutilazione dei genitali, i matrimoni combinati, i delitti di onore, non sono islamici; tuttavia è importante affermare che la donna è un soggetto autonomo padrone del proprio destino. Sul velo, non vi è forza nel sostenere che la Francia vuole escludere la religione dal pubblico dal momento che ha inibito l’esibizione in pubblico di vistosi simboli religiosi ; tuttavia è importante affermare che è antiislamico imporre il velo a una donna ed un attacco ai diritti dell’Uomo imporre di toglierlo. Sulle moschee, non è scritto con chiarezza che gli oneri relativi non devono essere sopportati dal pubblico per evitare il ritorno alla religione di stato; tuttavia è importante sostenere che nelle moschee i musulmani devono vivere serenamente l’appartenenza all’islam e nello stesso tempo coltivare una cittadinanza responsabile aperta a tutti i concittadini. Sul sentimento antiisraeliano, si può discutere l’attacco deciso alla politica di colonizzazione e di annessione dello Stato d’Israele, del resto accompagnata dall’attacco all’Arabia Saudita; tuttavia è importante scrivere che l’antisemitismo è per natura antiislamico.
Insomma, le analogie del libro di Ramadan con le nostre leggi e la nostra sensibilità sono notevoli. E non a caso il libro giunge ad affermare che “i due diritti fondamentali , la libertà di coscienza e la libertà di culto, sono riconosciuti e salvaguardati in tutte le società occidentali”. Così come argomenta che occorre spingere gli operatori dell’informazione a tener desta la propria coscienza civica nel momento in cui esercitano la professione, interessandosi ai processi più che alla cronaca, alle dinamiche di fondo più che agli scoop ed evitando di alimentare paure e fobie. Conseguentemente, verso la fine, il libro di Ramadan ripropone la sua riforma radicale affinché il musulmano passi da una fase di adattamento ad una fase creatrice di trasformazione. Il che richiede quelle che nel libro sono chiamate le sei “C” e cioè ” fiducia ( in altre lingue confiance o confidence) , coerenza, contributo, creatività. comunicazione, contestazione”. Con le sei C, il musulmano potrà sviluppare il superamento della crisi identitaria che ora lo attanaglia e comunicare serenamente con l’ambiente circostante imboccando la strada della ponderazione e della razionalità critica. Nel libro viene anche precisato che “è essenziale che nel corso di questa maturazione i musulmani non lascino campo libero alle voci più radicali, che monopolizzano i media e l’attenzione generale”.
L’obiettivo dichiarato delle tesi di Ramadan è che ciascun individuo perda il vizio di pensare possibile avere un’identità unica sia nell’ambito religioso-filosofico (cristiano o musulmano) che in quello della cittadinanza (inglese, francese, italiano). Comprendendo che sono l’ambito o il campo di attività a determinare l’identità operante. In ogni caso “tutte le culture – arabe, asiatiche e occidentali – devono tener desto lo spirito critico e autocritico”. ” Si tratta di essere aperti e nello stesso tempo critici”. Una simile attitudine non si limita alle persone ma si estende ai popoli. tanto che “l’Europa ha più bisogno non di un dialogo con le altre civiltà ma di un vero dialogo con sé stessa…. l’Europa deve riconciliarsi con le diverse componenti del suo passato per poter gestire il pluralismo necessario all’avvenire”.
Come si vede, dunque, è realistico pensare che le controversie su Tariq Ramadan derivino essenzialmente più che dalle sue idee, dal suo voler trattare dalla parte dei musulmani i rapporti con gli europei e l’occidente. Questa attitudine è contestabile solo partendo da un punto di vista di non musulmano che non vuol far crescere la presenza dei musulmani nel proprio paese. Però, una volta accettati dal musulmano i valori di cittadinanza, questo punto di vista non è più concepibile in chiave liberale. L’obiezione liberale al libro è piuttosto un’altra. Quella che, insistendo sempre sulla necessità di ricerca di senso per la propria vita, l’autore manifesta una propria legittima convinzione ma implicitamente focalizza l’attenzione non sui rapporti pubblici di convivenza ( che sono l’anima e la ragion d’essere del liberalismo ) quanto sul dare un modello di valori religiosi che possano formare quel senso di vita ( che è una ricerca rispettabile eppure necessariamente incline all’apostolato , di per sé distante dalla convivenza tra diversi).