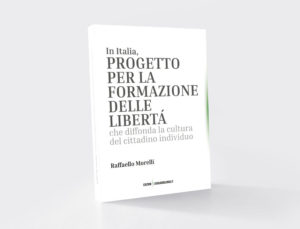In un articolo di Non Credo n. 21, ho sintetizzato il percorso logico di un mio libro (primavera 2012) in cui sostengo che è tempo di pensare ad evolvere sul tempo. I giganteschi passi in avanti nel conoscere, compiuti negli ultimi secoli, hanno fatto emergere la problematica sul tempo fisico, ma continuano a non usarne i caratteri. Il motivo di fondo è che gli strumenti matematici non lo includono. In proposito, nell’articolo richiamo due storici teoremi del ‘900 che sembrarono conferme indirette dell’impostazione platonica ma che in realtà ne esprimono i limiti nel rimanere estranei al tempo fisico.
Il primo è il fondamentale teorema logico di Goedel (1931). Prova che un sistema assiomatico privo di contraddizioni che descriva l’aritmetica dei numeri interi, è incompleto, vale a dire contiene aspetti che i suoi assiomi non possono confermare o negare. Detto altrimenti, in un sistema formale non contradittorio la contraddittorietà non è dimostrabile nel sistema. Ciò implica che la verità di un sistema non ha una ragione interna e quindi alcuni ne fanno conseguire che la verità andrebbe considerata qualcosa di innato o di fede. Il rigore della dimostrazione di Goedel è sicuro. Ma è altrettanto indubbio che la dimostrazione è concepita per restare nell’ambito della intuizione matematica e vorrebbe escludere ogni percezione con il mondo dei sensi.
Già questo escludere ciò che si percepisce con i sensi (dopo l’originario processo di astrazione da quello che è il mondo fisico) equivale ad un consapevole separarsi dalla realtà. Peraltro uso il termine “vorrebbe” perché, riflettendo sulla dimostrazione, emerge che non viene rispettata la prescelta condizione sistematica di essere estranea al tempo fisico. Infatti è certo che il concetto di infinito non trova riscontri nel mondo fisico e che la struttura dell’aritmetica non comprende concetti di tempo fisico. Ma poi, costruendo l’infinito come avanzamento inarrestabile del finito, si finisce per utilizzare un aspetto logico del tempo fisico anche nel mondo delle idee.
Per stare nell’infinito muovendo dal finito, il processo iterativo della successione numerica dovrebbe continuare ad essere reversibile, cioè poter procedere avanti ed indietro. Però questo non è possibile nell’infinito che ha più gradi di infinità: come scrivo nel libro, qui si opera su numeri infiniti stando in una dimensione infinita, che non è dello stesso genere del finito, non è con esso connessa, è da esso ben distinguibile e che anzi è stata inventata per fuoriuscire dalla gabbia del finito negandola. Ciò configura una palese irreversibilità. È la questione decisiva che determina l’incompletezza aritmetica, proprio perché una struttura partita dall’astrarre dal reale mondo fisico non riesce a star fuori dal tempo fisico (evitando di utilizzare sue procedure caratteristiche).
Insomma, il teorema di Goedel ha posto fine a una pluridecennale concezione positivista che pensava di determinare tutto con la ragione al posto del divino. Però non muta il piano operativo, che, in ambo i casi della ragione o del divino, non vuole tenere pieno conto delle percezioni sensoriali del mondo. A cominciare da quella più trascurata negli strumenti di comprensione della realtà, il tempo fisico. E, se ne tiene conto, rende impraticabile la teoria delle idee innate.
Il secondo è il celebre teorema logico sulla democrazia di Arrow (1951). Partendo da cinque condizioni in apparenza ovvie per definire la democrazia, dimostra che esiste una contraddizione insanabile e che la democrazia è impossibile. Implicitamente, il dibattere democratico sulla politica pubblica sarebbe una strada inutile se paragonata all’avere persone giuste che “sanno” quale è la verità delle cose e come fare per governare. Vale a dire, funzionerebbe meglio il potere ai gruppi che hanno i mezzi e i rapporti civili per “sapere” cosa è bene fare. Anche il rigore della dimostrazione di Arrow è sicuro (anni dopo ci ha preso il Nobel). Ma è altrettanto indubbio che ad un esame approfondito le cinque condizioni non costituiscono l’ovvia definizione della democrazia della convivenza, anche se ha segnato un progresso importante della riflessione sul come rappresentare la politica.
La decisione elettorale viene assunta salvo misurarsi con il proseguire della convivenza e quindi è provvisoria. Ha un prima, un presente e un dopo tra loro non simmetrici. Invece l’approccio del teorema si limita al ricondurre la decisione ai vincoli della logica di tipo formale applicata per convenzione ad una cosa concentrata in un punto. I pareri dei singoli vengono sommati uno per uno ma non si influenzano né prima né dopo la somma, in altre parole non sono quelli di esseri conviventi che interagiscono. Di più, il teorema riconosce il platonismo come una particolare funzione di benessere sociale in cui il processo di ordinamento sociale è rispettato da ogni processo di ordinamento individuale, in pratica presuppone il conformismo. In effetti, ambedue, platonismo e funzione di benessere sociale, escludono il tempo irreversibile e non prendono in considerazione il fluire del conflitto democratico, che si incardina nelle interrelazioni reciproche.
Non a caso il teorema esplicita la precondizione del rispetto della transitività e la transitività, nella vita reale, non è affatto un’assunzione neutra. Chiedere la transitività significa chiedere che sia possibile il raffronto, di fatto, che le decisioni assunte prima comportino in automatico quelle successive. Non si chiede solo lo stesso tipo di processo decisionale, si suppone che non siano mutate le condizioni di spazio e di tempo in cui opera il processo decisionale. E ciò contrasta l’esperienza quotidiana. Ricercare la funzione di benessere sociale attraverso il voto – che è un sistema dotato di tempo irreversibile – insieme richiedendo il rispetto della transitività, significa chiedere che le condizioni non mutino, cioè sterilizzare il tempo fisico.
Questa impostazione distorta si traduce nelle cinque condizioni da rispettare. La Condizione 1 non considera il tempo e chiede che, ad una completa libertà di ordinamento preferenziale dei singoli, corrisponda sempre una funzione di benessere sociale. E siccome questa funzione è transitiva per definizione, si intendono esclusi gli ordinamenti singoli che non siano transitivi (una discriminazione che contrasta con la diversità individuale). Inoltre, questa richiesta introduce l’idea che la funzione di benessere sociale non è una specifica scelta provvisoria ma qualcosa di organico capace di sistemare/raccordare le preferenze di tutti. Ora, disconoscere l’idea di scelta equivale a trasformare la funzione da rappresentanza della realtà a manto sulla realtà. Ed inoltre, un simile assunto, richiedendo la funzione sociale capace di sistemare tutti, riprende la strada di progressiva restrizione nella convivenza del ruolo dei diversi singoli e dello sperimentare. Che ciascuno abbia le proprie preferenze e le esprima, non comporta che la funzione di benessere sociale rispetti tutte le preferenze. Nella realtà le preferenze di ciascun cittadino convivono con quelle degli altri, e il voto costituisce una scelta specifica a maggioranza, rivedibile in seguito e limitata all’argomento, non estesa a tutti gli argomenti.
Con la Condizione 2 il teorema richiede che tra due alternative, qualora l’ordine di preferenza resti lo stesso per tutti i singoli, la funzione di benessere sociale mantenga la medesima corrispondenza. Il che vuol dire porre il vincolo di rispettare le decisioni unanimi ma tace sulle altre, che peraltro nella realtà sono quasi il 100%. Con la Condizione 3, il teorema, al fine di stabilire l’indipendenza dalle alternative irrilevanti, stabilisce che, anche qualora muti l’ordine di preferenza dei singoli su un insieme di alternative, non cambi la funzione di benessere sociale relativa alle alternative che non fanno parte di quell’insieme. Il che vuol dire porre il vincolo irrealistico di non considerare le valutazioni complessive di convivenza, che ciascuno fa su una serie di parametri alternativi non considerabili sempre tra di loro irrilevanti (il fatto che si voti a proposito di una alternativa, non significa che non si possa ritenere influente un cambiamento di giudizio intervenuto sulle altre). Insomma, le Condizioni 2 e 3 del TKA mirano ad una funzione di benessere sociale che suppone un rispetto «guidato» delle preferenze individuali, in sostanza restando fuori della effettiva diversità individuale legata al tempo fisico.
Per finire, il teorema pone le condizioni che la funzione di benessere sociale non debba essere imposta (Condizione 4) e che non sia dittatoriale (Condizione 5). Tuttavia, quanto alla non imposizione, vuole esprimere il principio di sovranità dei cittadini, con lo stabilire che, in qualsiasi ordine preferenziale dei singoli, non deve esistere qualche coppia di alternative distinte per cui la funzione di benessere sociale rende l’una preferita o indifferente all’altra. Tale formula esclude la forma estrema del platonismo ma permette quella serpeggiante del prevalere di conformismo sociale immobilista e ostile al cambiamento (e quindi al tempo fisico). Quanto all’impedire un regime dittatoriale, vuole farlo evitando che ci possa essere un singolo la cui preferenza, per ogni coppia di alternative, divenga la funzione di benessere sociale a prescindere delle preferenze degli altri individui. Tale formula, di nuovo non preoccupandosi della realtà concreta, costituisce una definizione molto superficiale della attitudine dittatoriale, perfino sovrapponendosi all’esercizio di forti capacità di indirizzo politico.
Eppure l’insieme di queste condizioni, che il teorema definisce «evidentemente ragionevoli», provoca già la dimostrata impossibilità che esista una funzione di benessere sociale che le soddisfi tutte contemporaneamente. Solo che quelle condizioni, più che essere evidentemente ragionevoli, si riferiscono ad una concezione statica del cittadino e delle interrelazioni civili – contraddittoria sulla diversità individuale e sul presupposto di un medesimo ordinamento preferito da tutti – che non tengono conto della vita reale. La dimostrazione resta nell’ambito della logica teorica e non riproduce la convivenza vera. Insomma, il teorema di Arrow ha posto fine all’uso secolare del confrontarsi politico senza ragionare sulle condizioni logiche del confronto, e tuttavia, ponendo condizioni non realistiche, asserisce che la democrazia è impossibile, giustificando le precedenti procedure non fondate sul progetto di autodeterminazione del cittadino. Solo che, così, non muta il piano del ragionare, che resta il non tener conto di continuo delle percezioni sensoriali del mondo e dei cittadini quali effettivamente sono. A cominciare dalla cosa più trascurata negli strumenti di comprensione della realtà, il tempo fisico che scorre in avanti.
Il richiamo di questi due teoremi nel mio libro evidenzia un fatto preciso. Continuare ad usare l’ottica abituale del definire un modello fuori del tempo come obiettivo culmine del conoscere, non funziona più. Nel caso di Goedel, perché un sistema non può dimostrare sé stesso e necessita di nuovi punti di vista, nel caso di Arrow perché condizioni ovvie ma non rispettose del mondo rendono impossibile la democrazia: ambedue concezioni teoriche ed irreali. In pratica, la pretesa platonica di impegnarsi per scoprire le idee innate del mondo, non può più essere utilizzata per viverlo. E dunque non possono funzionare tutte le impostazioni analoghe. E’ necessario mutare approccio. Continuare a cercare di conoscere il mondo circostante e di approfondire il funzionamento dei nostri rapporti interindividuali non è più fecondo se, insieme, non si muta parametro e si cerca di compenetrare la natura del tempo fisico irreversibile, fin qui trascurata.
E’ evidente che è estremamente difficile. Però è una strada obbligata per adoperare anche in altri settori il metodo per cui la conoscenza scientifica funziona sempre. Funziona perché si fonda sui risultati sperimentali e non sulle dottrine assunte come verità. Fondandosi sui fatti sperimentali, ha cominciato a tener conto di continuo del passare del tempo fisico. E anche ad abbandonare la pretesa di conoscere ogni cosa (ci si limita a quelle sperimentabili) e di volerla conoscerla per sempre. Questo metodo “umile” e cosciente dei suoi limiti, va allargato in ogni campo conoscitivo e operativo.
Intanto porta ad ipotizzare un quadro generale di riferimento. Primo, la realtà esterna ad ogni essere vivente ha una consistenza materiale e una durata di dimensioni più ampie che non gli esseri viventi; secondo, gli esseri viventi umani sono immersi in quella realtà e sono evoluti in modo da poter esercitare un ruolo di conoscenza – della realtà esterna, degli altri esseri viventi e dei rapporti interpersonali – assai più penetrante degli altri; terzo, il ruolo di conoscenza si svolge attraverso l’impulso elaborativo individuale degli umani filtrato con le valutazioni altrui, così da sperimentare la validità di quanto astratto e da intercettare i cambiamenti al passare del tempo fisico.
Con questo quadro si riesce a coniugare l’esperienza sensoriale con la capacità riflessiva della mente individuale e si mantiene quest’ultima connessa con il riscontro nell’ambito fisico. Perché la percezione della mente non è separabile dalla percezione del mondo, ne dipende e per questa via segue l’evolversi nel tempo. Dunque la capacità matematica, per riprodurre il mondo, deve riuscire a cogliere gli aspetti del tempo che scorre.
pubblicato sullarivista NON CREDO n.22