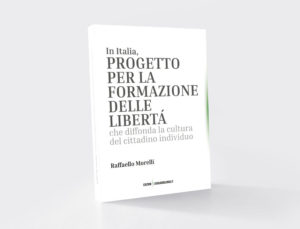L’articolo di Eugenio Scalfari uscito il 27 giugno su Repubblica prende spunto dall’attualità (“in questi giorni si è fatto un gran parlare dello Stato italiano e Draghi ha ribadito che siamo uno Stato laico”), per riproporre un altro articolo dello stesso autore scritto all’epoca del 150° dell’Unità, nel quale ricorda i momenti definiti più affascinanti del nostro Risorgimento. Motivando “per non dimenticare da dove veniamo”. La frase è come minimo molto ambigua, dato che la ricostruzione del Risorgimento fatta nell’articolo non consente di ricordare da dove veniamo, siccome del Risorgimento Scalfari omette il senso politico effettivo, elencandone solo i passaggi di cronaca nel quadro di una sottesa ed anacronistica prospettiva consociativa.
Per fare questo, Scalfari intanto tarpa la frase di Draghi nell’aula del Senato, che , intera, dice “il nostro è uno Stato laico, non confessionale “. Dunque toglie “non confessionale”, il che gli permette di non trattare nell’articolo la principale questione politico civile sottostante, derubricandola ad ostilità al Risorgimento del Vaticano e dei cattolici, che contribuiva ad aggravare le altre mancanze del Regno d’Italia su cui invece si sofferma (e tornerò in seguito su questo artificio funzionale).
Poi, Scalfari avvia la sua ricostruzione del Risorgimento fondandola sull’ interpretare strumentalmente un brano della scrittrice Ingeborg Bachmann “in ogni testa c’è un mondo e ci sono delle aspirazioni che escludono qualsiasi altro mondo e qualsiasi altra aspirazione. Eppure noi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri se vogliamo che qualcosa vada a buon fine“. Il brano letteralmente esprime la necessità che ogni convinzione individuale, pur diversa, sia consapevole di doversi rapportare agli altri per avere efficacia (quindi è un’osservazione realistica delle relazioni tra i conviventi nella diversità, condivisa in pieno dall’intera cultura laica). Scalfari, invece, la interpreta contrapponendo in modo esplicito i due periodi.
Il primo significherebbe che si sta “svolgendo da anni una lotta di tutti contro tutti per la conquista dell’egemonia e del potere, il suo rafforzamento e la sua estensione, senza più alcun disegno del bene comune “. E specifica che un simile atteggiamento è dominante nella scena della politica, dell’economia e del sociale, come le condizioni italiane odierne dimostrano inequivocabilmente. Solo che esprimere concezioni di questo tipo, equivale a rifiutare la realtà del mondo. Perché nel mondo reale domina il conflitto tra individui conviventi e la sfida politica vera è , in ogni epoca, trovare il sistema di farlo svolgere secondo norme sempre più maturate ed espresse per via democratica., cioè dagli stessi cittadini Quanto al secondo periodo del brano, significherebbe che la soluzione alle lotte del tutti contro tutti indicate nel primo, starebbe nel disporre di un disegno di bene comune. Peccato, secondo Scalfari, che tale soluzione “è stata del tutto cancellata dallo spirito della nazione”. Solo che questa tesi del bene comune contraddice l’esperienza storica. Il bene comune non è mai scelto dai cittadini e in democrazia non può venire imposto. Invece fanno la differenza e fanno progredire, i risultati tangibili delle iniziative assunte dai cittadini nel quadro delle condizioni rese possibili dalle istituzioni.
Tale impostazione irrealistica, non è fortuita. Consente a Scalfari di evitare il metodo sperimentale dell’osservare i fatti come all’epoca avvenuti nel tempo. E in conseguenza di non far cenno al disegno politico culturale del Risorgimento che ne ha determinato il successo. La ricostruzione di Scalfari diluisce nei decenni e affastella a mò di cronaca i fatti, senza mai evidenziare quelli determinanti nel concretizzare il disegno unitario. Perché voleva sorvolare su questa cosa. Lui non cerca di illustrare il Risorgimento. Ma di far sembrare che il Risorgimento sia stato un episodio (neppure riuscito bene, fa intendere) da ricordare solo per i principi (i tre della rivoluzione francese) e per il tricolore (della repubblica Cisalpina), dato che, parole di Scalfari, la bandiera dei tre colori è l’icona della continuità ideale tra l’unità del Paese e i valori culturali della modernità. Eppure va rilevato che questi due fattori sono ambedue antecedenti al Risorgimento maturo di oltre mezzo secolo e non sono certo frutto del Risorgimento.
Scalfari scrive che il Risorgimento fu un esempio della collaborazione degli uni con gli altri affinché qualcosa andasse a buon fine. Queste parole paiono un’ovvietà, ma la sua evidente intenzione è riferirle ad un’epoca di collaborazione intesa come assenza di contrasti, accantonati in virtù di un disegno di bene comune. Che sarebbe il logo del Risorgimento. Questa fantasiosa visione idilliaca non può venir disturbata dall’approfondire lo storico contrasto con il Vaticano, che sarebbe emerso se, nel riferimento a Draghi, avesse mantenuto il non essere l’Italia un paese confessionale. Peraltro quel contrasto non solo fu così forte da perdurare immutato nella sua dura preclusione antirisorgimentale per quasi settanta anni e da allora fino ad oggi con nuove modalità seppure meno eclatanti, ma principalmente costituì un aspetto caratterizzante l’intera chiave di volta del successo del Risorgimento nel puntare all’Unità dell’Italia. Del tutto difforme da quel disegno di bene comune cui vorrebbe far credere Scalfari.
Nel lungo periodo del Risorgimento progressivamente si radicò l’idea dell’Italia. Ma non ha senso elencare tutte le posizioni senza mettere in rilievo il valore politico chiave che consentì di arrivare alla meta. Addirittura omettendolo. Il valore politico chiave fu l’incrollabile impegno di Cavour nel costruire con paziente determinazione in ambito europeo le condizioni politiche adatte a consentire l’Unità dell’Italia; e con altrettanta cura, in ambito interno italiano, le condizioni per introdurre via via di più nella vita pubblica l’esercizio della libertà del cittadino: a livello dei vari stati, restando fermo sul percorso dei molti plebisciti per le annessioni al Regno di Sardegna e , a livello dello stesso Regno di Sardegna, per praticare il principio (già consolidato in Inghilterra) che i governi dipendono dalla volontà del Parlamento e non da quella del Re. Proprio questo impegno sull’estendere la libertà dei cittadini, ha determinato la formula Libera Chiesa in Libero Stato, intorno cui è sorto il contrasto con il Vaticano (Scalfari non ne fa cenno) ed è la radice della feconda pratica del separatismo Stato religioni (il cui simbolo è la presa di Porta Pia, qui ignorata da Scalfari), che nell’ultimo trentennio è stata riconosciuta come principio di fondo anche dalla Corte Costituzionale.
Questa caratteristica, l’allora Presidente Napolitano la riassunse così. “La grandezza del moto unitario sta precisamente nella ricchezza e molteplicità delle sue ispirazioni e delle sue componenti, la grandezza di Cavour sta nell’aver saputo governare quella dialettica di posizioni e di spinte, nell’aver saputo padroneggiare quel processo fino a condurlo al suo sbocco più avanzato”. Richiamando ulteriormente “il carattere aperto e dinamico del disegno cavourriano, che non abbracciò immediatamente la ricerca dell’intera unità d’Italia, ma si allargò via via in modo da comprendere e cogliere tutte le esigenze che emergevano dallo sviluppo stesso dell’impresa originaria e dall’evolversi dello scacchiere europeo.”
Il punto è che nella vita reale il conflitto democratico è sempre presente e la sfida è incanalarlo per raggiungere il risultato voluto. La guida di Cavour fece centrare l’obiettivo al Risorgimento organizzando il convergere dei diversi. E consiste esattamente in questo impegno alla costruzione delle istituzioni democratiche aggiornandole, che sta l’effettiva icona della continuità ideale tra l’unità del Paese e i valori culturali della modernità (riprendendo le parole usate da Scalfari). Che è poi la sostanza di quanto detto da Napolitano nel testo sopra. Scalfari sorvola su tutto ciò e distorce l’idea di laicità del Risorgimento cui l’articolo è intitolato. Tanto che deve prendere le distanze anche da Napolitano. Del quale richiama il giudizio secondo cui il moto risorgimentale sboccato nell’Unità ha di gran lunga migliorato le condizioni non solo del Nord ma anche del Sud. Annotando però “è certamente così in termini assoluti, ma non lo è in termini relativi”, subito dopo citando le criticità dei giorni nostri, in specie dei giovani. Perché la stella polare di Scalfari è la concezione totalizzante del disegno di un bene comune definito una volta per tutte. E questo non è laicità. E’ il suo opposto. Il consociativismo.
Trattare il Risorgimento in modo distorto serve a Scalfari per innescare una ricostruzione sbagliata del da dove veniamo. Vuole che gli italiani si riconoscano in una patria come luogo in cui opera il bene comune di un’identità dedita al conformismo ossequioso del potere, a qualunque livello, non al conoscere e al misurarsi nel conflitto. In questa maniera, vuol rafforzare l’inclinazione a vivere secondo la prospettiva consociativa dell’incontro tra l’ideologia e la religione, dal quale viene soffocato il più possibile l’apporto dell’individuo, che, in quanto tale, costituisce il nemico da battere, perché emblema del disordine della diversità e del rifiuto dell’unità sul vero utopico.
Con tale obiettivo, Scalfari definisce laicità del Risorgimento idee e comportamenti che non sono né laici né risorgimentali. Perché laicità e Risorgimento hanno avviato – in un paese con la radicata tradizione culturale dell’inquisizione e della rigidità cattolica – un processo del tutto contrastante con la logica del bene comune e del conformismo. Il processo che consiste nell’impegnarsi a costruire le condizioni dello stato dei diritti di cittadinanza piuttosto che dell’assistenzialismo, e a diffonderne il senso di appartenenza civile da adeguare nel tempo.
Il volontario depistaggio consociativo rispolverato da Scalfari con questo articolo è un vergognoso falso storico di cui Non Credo intende segnalare la pericolosità nel formare le nuove generazioni. In chiave laica, certo, ma pure sotto il profilo più genericamente civile. Sono falsi di questo tipo che aiutano le manovre serpeggianti di permanente avversione allo Stato “nemico”, promosse da chi si ostina a non riconoscere che la nostra libertà di cittadini non si potrebbe realizzare senza uno Stato fondato sulle nostre decisioni. Come fanno le istituzioni laiche.